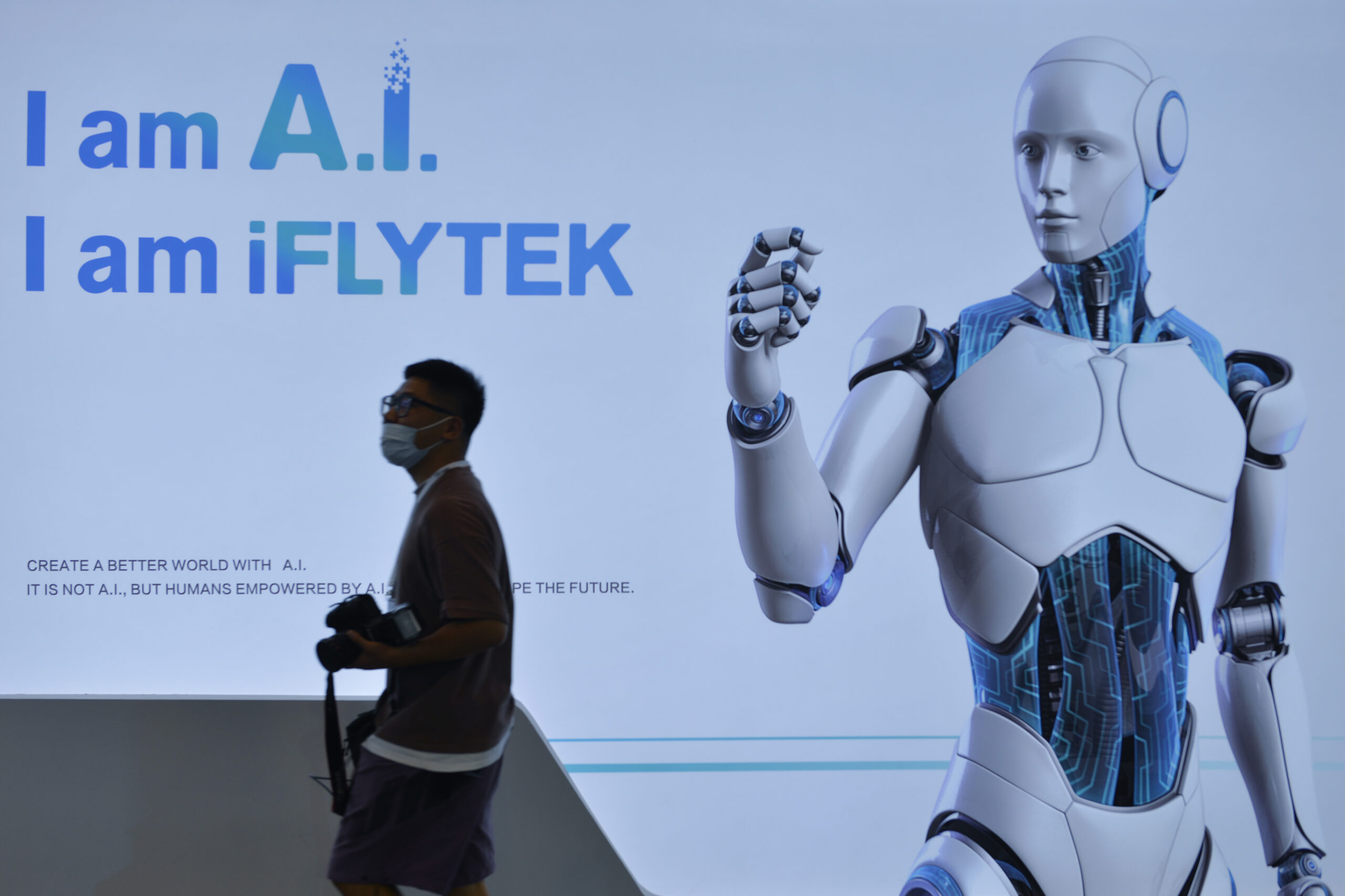Lo scorso marzo è entrata in vigore la prima legge al mondo che disciplina i codici per l’Intelligenza Artificiale (I.A.). Il provvedimento, l’Internet Information Service Algorithmic Recommendation Management Provisions, è stato varato dalla Cina ed era in bozza dall’anno scorso.
La legge, sostanzialmente, rende di pubblico dominio gli algoritmi usati in qualsiasi piattaforma tecnologica ed è nata dall’esigenza di controllare alcuni problemi come la diffusione di notizie false o arginare alcune non meglio definite “attività illegali”.
Il Dipartimento Statale per le Informazioni su Internet cinese diventa così responsabile della pianificazione generale e del coordinamento della governance nazionale dei servizi di raccomandazione algoritmica – intendendo con questi termini l’I.A. che, ad esempio, consiglia gli acquisti sul web – e delle relative attività di supervisione e gestione. Sulla base dei rispettivi compiti, i dipartimenti competenti del Consiglio di Stato, come le telecomunicazioni, la pubblica sicurezza e la regolamentazione del mercato, sono responsabili degli sforzi per supervisionare e gestire i servizi di raccomandazione algoritmica.
Pechino ha stabilito di creare un registro pubblico dei codici algoritmici, dove le società sono obbligate a descriverne il funzionamento, sia per censirli, sia per avere un controllo diretto sui meccanismi di questa tecnologia che utilizza l’I.A. Detto in altri termini, la Cina ha reso pubblico uno strumento tecnologico dirompente come gli algoritmi che governano l’Intelligenza Artificiale per poterlo controllare meglio. Lo Stato, quindi, potrà intervenire direttamente sugli obiettivi degli algoritmi ordinandone la modifica in caso questi contrastino con i valori del politburo.
Si tratta solo dell’ultimo provvedimento preso dal governo cinese per la gestione e il controllo dei “big data”: nel 2017 è stata emanata una legge sulla cybersecurity, mentre nel 2021 è stata regolamentata la protezione dei dati e la privacy.
Avere normato l’ambiente informatico prima di altri attori, pone la Cina in vantaggio: dal punto di vista commerciale viene tutelato il mercato interno, mentre dal punto di vista strategico permette a Pechino di agire disinvoltamente nella Cyber Warfare acquisendo in modo semplice le informazioni tecnologiche legate ai codici sorgente di quei soggetti che intendono operare in Cina.
Lo scopo quindi è duplice: controllare la possibile deriva liberale del cyberspazio, impostandolo in modo “sostenibile” secondo la dottrina del Pcc (Partito Comunista Cinese) e usare i dati per obiettivi strategici in modo da far diventare la Cina una superpotenza tecnologica guidata dal Politburo.
In questa trattazione non intendiamo affrontare gli aspetti etici oppure quelli più strettamente tecnici dell’utilizzo dell’I.A in quanto già esposti in precedenza: riassumendo, questo provvedimento potrebbe essere funzionale anche al miglioramento del funzionamento degli algoritmi, che sono ancora soggetti a pregiudizi di tipo “umano”, e a circoscrivere la responsabilità del loro utilizzo, che ancora oggi non è stata definita in sede giuridica.
Vogliamo invece soffermarci sulle possibili implicazioni legate al confronto tra Cina e Stati Uniti, che porta con sé conseguenze anche per l’Europa. Per farlo partiamo da un assunto espresso nel 2018 dall’allora segretario alla Difesa Usa, il generale James “mad dog” Mattis: “Per decenni gli Stati Uniti hanno goduto di una superiorità incontrastata o dominante in ogni ambito operativo. In genere potevamo schierare le nostre forze quando volevamo, assemblarle dove volevamo e operare come volevamo. Oggi ogni dominio è conteso: aria, terra, mare, spazio e cyberspazio”.
Una tesi ribadita recentemente anche da un profondo studioso statunitense dei rapporti sino-americani, il professor Graham Allison, che in una recente intervista ha affermato, parlando proprio di Intelligenza Artificiale, che “nello spazio dell’I.A. se disponi di un sistema di Intelligenza Artificiale più efficace in grado di far sì che un pezzo di equipaggiamento militare, ad esempio in un combattimento aria-aria, risponda più rapidamente del pilota dell’aereo avversario, vinci, quindi questi avere applicazioni militari”.
L’allarme era stato già lanciato esattamente un anno fa da Nicolas Chaillan, il primo chief software officer del Pentagono che si era dimesso per protestare contro il lento ritmo della trasformazione tecnologica nell’esercito degli Stati Uniti. Sebbene gli allarmi siano tendenzialmente esagerati, stante i progressi dimostrati e dimostrabili compiuti dagli Usa in questo campo, l’Occidente parte in svantaggio sia per la mancanza di un chiaro ed elastico aspetto normativo, sia per la stessa impostazione della società, molto più attenta all’aspetto “umano” rispetto a quella cinese quando si tratta delle applicazioni pragmatiche dell’I.A. nel settore militare.
Pechino – così come Mosca – a differenza dell’Occidente sta optando per una gestione dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi bellici secondo il principio Human-out-of-the-loop, ovvero che affida agli algoritmi la totale gestione della macchina. Analisti e scienziati cinesi, infatti, ritengono che si arriverà a una “singolarità” sul campo di battaglia quando l’uomo non sarà più in grado di tenere il passo con la velocità operativa delle macchine, per cui il principio Human-in-the-loop diventerà uno svantaggio.
Il provvedimento recentemente entrato in vigore in Cina, quindi, potenzialmente avrà effetti dirompenti nel settore dell’I.A. applicata alla Difesa, permettendo di captare i codici sorgenti di tutte le società che operano in Cina e così poterli eventualmente sviluppare ed applicare nel campo degli armamenti. La subordinazione del settore “privato”, ammesso che si possa definire tale in un Paese come la Cina, a quello pubblico diventa pertanto un vantaggio fondamentale se consideriamo la riluttanza di alcune delle maggiori aziende occidentali – come Google – a collaborare con lo Stato quando si tratta di ricerca ad alta tecnologia nel settore informatico. Una riluttanza determinata dalla mancanza di un ordinamento giuridico dedicato, che ancora oggi fatica a essere definito sia negli Stati Uniti sia in Europa.