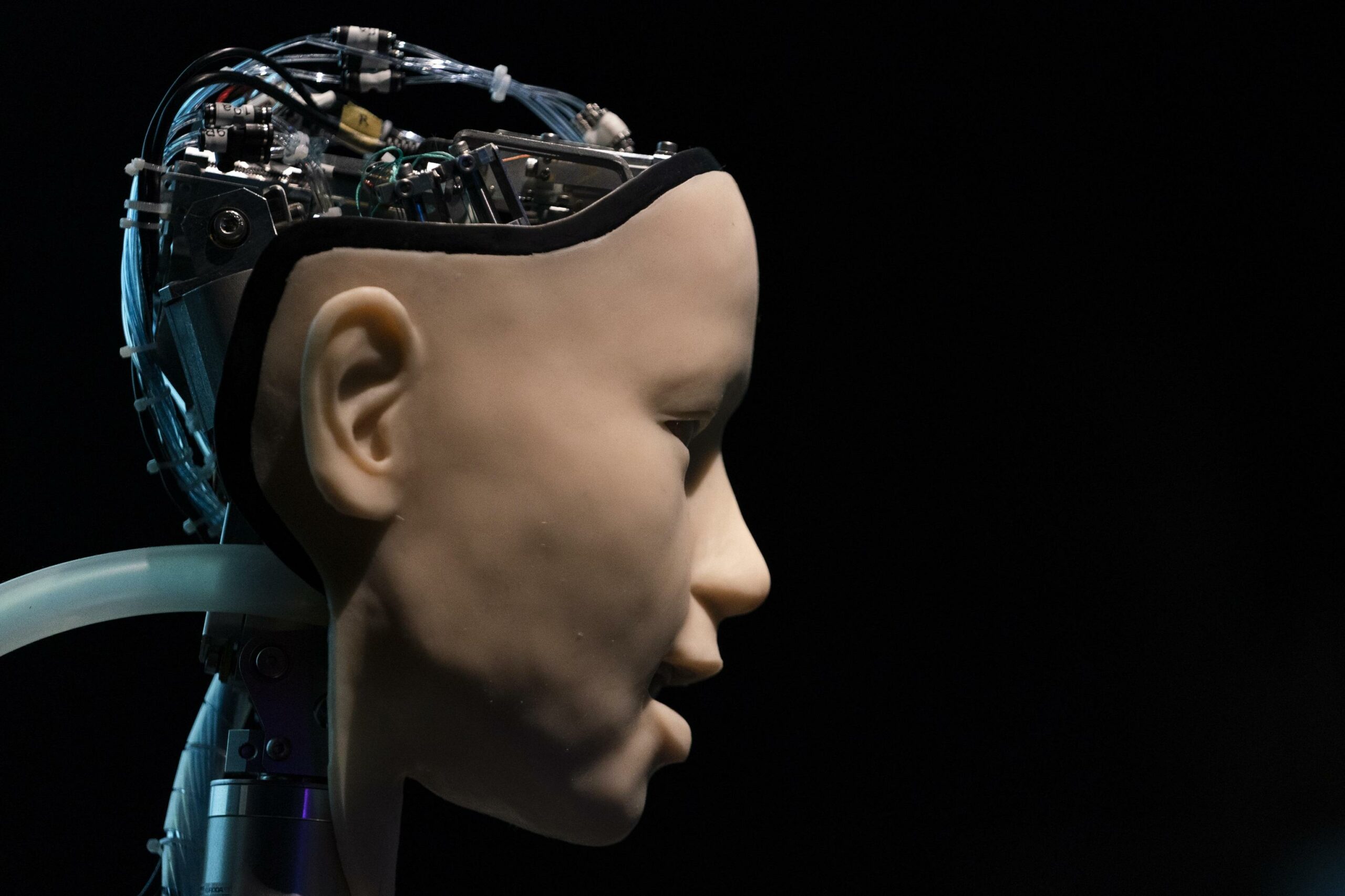A Washington non si parla abbastanza delle policy relative a Big Tech, nemmeno lontanamente. Questioni politicamente scottanti come la censura ed il monopolio tendono a dominare la conversazione, ma l’Era dell’informazione ha profondamente trasformato il modo in cui gli esseri umani interagiscono, come i bambini crescono, come i mercati funzionano, e come la nostra vita sociale e al tempo stesso politica si dispieghi. La Rivoluzione informativa, come la Rivoluzione industriale prima di essa, richiede un’ampia visione di policy al passo coi tempi. E nella fase di sviluppo di tale visione, i policymaker devono anche tenere a mente una verità essenziale che mina la loro consueta fiducia nella capacità dei mercati di risolvere problemi: ovvero, che le forze di mercato da sole non massimizzano la prosperità umana e che non ogni bene appartiene ad un mercato.
All’interno del loro libro Economia Civile, i professori di economia Luigino Bruni e Stefano Zamagni si rifanno alla tradizione filosofica italiana per descrivere un vecchio concetto di mercato spesso trascurato: “Nella realtà dei fatti i mercati”, ci ricordano, “non sono mai eticamente neutrali; o sono civili o sono incivili”. Con “civili”, Bruni e Zamagni non intendono “educati”, bensì “civilizzanti”. O i mercati funzionano in base alla propria “antica vocazione originale, come alleati del bene comune, rappresentando uno spazio di libertà, socialità ed espressione delle nostre capacità…come persone”, e sono dunque civili, oppure non lo sono, e invece “sono alla ricerca compulsiva della ricchezza anziché della felicità collettiva, e… dimenticano e distruggono tali beni economici fondamentali, relazionali, comuni e gratuiti”. Molti dei cambiamenti che l’Era dell’Informazione ha portato con sé sono, in questo senso, incivili.
I governi democratici hanno il dovere di correggere questa situazione. I leader tecnologici preferirebbero che noi credessimo che qualsiasi danno provocato dai loro prodotti e dalle loro pratiche siano il prezzo inevitabile da pagare per il progresso, che il mercato neutrale abbia parlato, e che il ruolo del governo sia di levarsi di mezzo dal suo percorso. Ciò oscurerebbe la realtà dei fatti, ovvero che permettere al progresso tecnologico di realizzarsi in modalità che possano danneggiare il benessere individuale, la prosperità economica collettiva, l’integrità del nostro tessuto sociale condiviso e le nostre libertà politiche sia una scelta, per l’appunto, politica. Noi possiamo e dovremmo compiere scelte migliori, tenendo in considerazione diversi principi fondamentali.
Il primo è che una nazione libera e prospera ha il dovere di difendere i propri figli
I bambini meritano una sfera di protezione all’interno della quale crescere e svilupparsi in sicurezza, ma d’altra parte è sempre più evidente come la migrazione di massa della vita sociale infantile verso il mondo virtuale dei social media abbia provocato loro un male profondo, e ciò non può essere tollerato. Il mondo virtuale in cui Big Tech induce i bambini a trasferirsi non è stato progettato a loro beneficio, ma per catturare la loro attenzione e trarne dei profitti a scapito del loro benessere. Il mercato non è stato punito per questo danno, tutt’altro: adesso è effettivamente al di fuori della portata dei genitori allontanare volontariamente i propri figli dai social media, e dal punto di vista dei bambini, il prodotto è appositamente realizzato per creare dipendenza e renderli dipendenti dal suo utilizzo. Urge dunque l’intervento di apposite policy: normalmente non si aspetta che sia il mercato a risolvere questioni di sicurezza infantile, e tantomeno si sacrificano i bambini nel nome di “innovazione” o “crescita”, e non dovrebbe essere questo il caso.
Le policy pubbliche devono inoltre proteggere il diritto delle persone a godere di una vita privata a cui né lo Stato né il mercato abbiano accesso. Una questione di privacy personale, indubbiamente, ma anche di autonomia. L’ingente mole di dati personali a disposizione delle multinazionali (e in molti casi anche dei governi) offre terrificanti opportunità per manipolare i modi sia di pensare che di agire. Un tale utilizzo di dati personali, specialmente quando non è stato consensualmente ed affermativamente divulgato per tale scopo, è immorale e pericoloso. Eppure la fornitura di tali dati, sebbene in alcuni casi sia tecnicamente “volontaria”, in America è sistematicamente diventata il biglietto d’ingresso necessario per accedere alla vita sia sociale che professionale, rendendo difficile compiere delle scelte in autonomia, ed è difficile esprimere un vero e proprio consenso in un ambiente in cui i dati personali, una volta forniti, abbandonano di fatto il controllo dell’individuo a cui appartengono. Una vera democrazia non dovrebbe permettere al mercato di invadere la privacy dei propri cittadini, e nemmeno l’autonomia personale di cui la loro privacy è una precondizione necessaria.
I cittadini devono controllare la tecnologia, e non il contrario
Parafrasando il Nuovo Testamento, gli esseri umani non furono fatti per la tecnologia, ma è la tecnologia ad essere stata fatta per gli esseri umani. Gli algoritmi possono migliorare la forza di decision-making in modalità interessanti, ma il loro utilizzo deve rimanere soggetto al giudizio umano e ad una riflessione democratica. La mancanza di una corretta supervisione dell’utilizzo degli algoritmi nell’inseguimento dell’efficienza di mercato comporta ingiustizie ed indignazioni inaccettabili ma evitabili, come nei casi in cui gli algoritmi del sistema sanitario volti a migliorarne l’efficienza amministrativa offrono supporto in maniera discriminatoria dal punto di vista razziale, o in cui gli algoritmi per l’assunzione del personale scartano candidati qualificati ma non tradizionali prima ancora che la loro richiesta possa essere esaminata dall’occhio umano.
Infine, il diritto delle nazioni di creare ed implementare le proprie leggi, proteggere i propri cittadini, e sorreggere i propri valori non dovrebbe essere oggetto di compravendita
Eppure il mercato tecnologico globale ignora l’integrità delle prerogative nazionali. Alle aziende tech statunitensi non deve essere concesso di aggirare le leggi e i valori degli Stati Uniti semplicemente perché ritengono che sia il proprio modello di business ad esigerlo; e allo stesso modo, le aziende straniere intenzionate a condurre affari negli Usa alle leggi americane scritte negli interessi dei propri cittadini.
Si intravedono segnali di speranza. Negli ultimi mesi, in risposta alle preoccupazioni e al crescente malcontento del pubblico statunitense, i policymaker americani sono stati alle prese con interrogativi sempre più complessi su cosa potrebbe implicare una migliore gestione dell’Era dell’Informazione, e devono continuare ad approfondire tali concetti finché non saranno stati sviluppati abbastanza da controllare adeguatamente Big Tech.
Chris Griswold è Policy Director presso l’American Compass. @Chris_Griz – Ulteriore materiale su questo argomento è disponibile su americancompass.org/technology