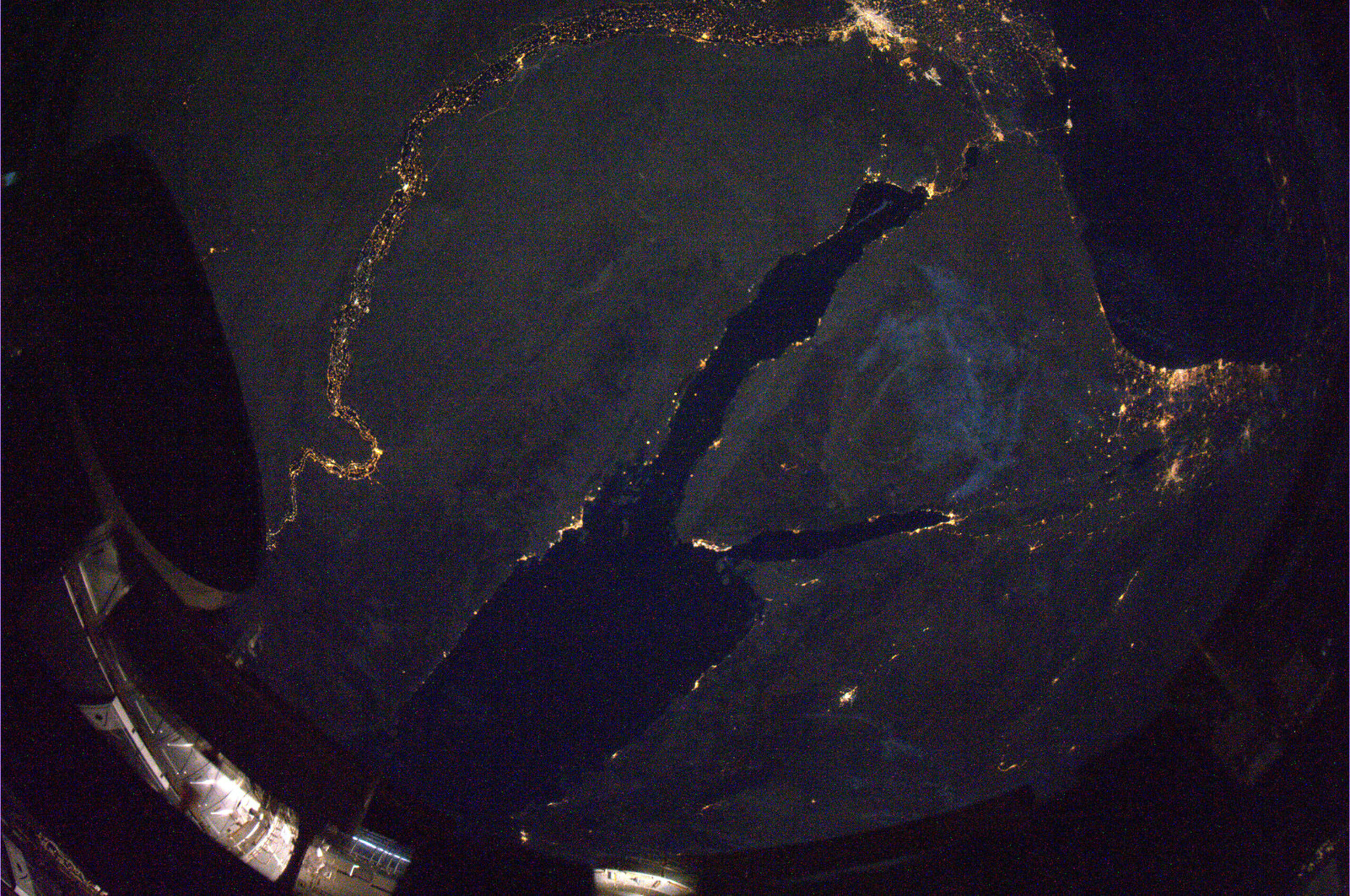Il 20 maggio 1498 una caravella e tre caracche comandate da Vasco da Gama raggiunsero, dopo aver circumnavigando faticosamente l’Africa, il porto di Calicut nell’India sud occidentale. Fu un’impresa straordinaria che spezzò il dominio islamico sull’Oceano Indiano. Per sempre. La via delle Indie era di nuovo aperta e divenne la Carreira da India, trasformando in pochi anni un periferico reame incuneato ai bordi estremi dell’Europa nella principale potenza navale, militare ed economica del tempo.
Infranto il monopolio arabo sul commercio delle spezie, le “scintille d’Oriente”, gli equilibri euroasiatici si frantumarono velocemente: fondaci, porti e angiporti e persino la mitica via della seta, con le sue carovane provenienti dalla favolosa Cina, divennero obsoleti, superati. In pochi anni, i lusitani, sotto la guida di De Gama, Pedro Alvares Cabral e Alfonso de Albuquerque, piantarono le loro spade e innalzarono croci e stendardi a Malindi, a Ormuz, a Goa e Diu, a Ceylon per poi inoltrarsi nello stretto di Malacca e veleggiare verso le Molucche, Timor, Macao, sino a toccare, nel 1543, Nagasaki, il misterioso Giappone. Un mondo nuovo era nato.
I veneziani, i mamelucchi egiziani e gli ottomani faticarono a comprendere la portata dell’evento. Nell’agosto del 1499 giunsero in laguna le prime notizie sull’impresa dei lusitani. Disorientati e un po’ scettici, i governanti tardarono nelle decisioni, ma, nel luglio 1501, da Lisbona giunse la conferma definitiva. A novembre si seppe che l’ammiraglio Cabral – il comandante della seconda spedizione portoghese – era tornato in patria con un carico straordinario: 100 tonnellate di pepe e 20 di zenzero, insieme a casse di chiodi di garofano, gommalacca e resina di benzoino. Il diarista veneziano, Girolamo Priuli, così annotò l’eco provocato: “Tuta la citade se ne risentite grandemente e chadauno rimaxe stupefatto et fo tenuto questa nova per li sapienti che la fusse la peggior nova, che mai la Repubblica Veneta potesse aver abuto”.
Il 5 gennaio 1502 il Consiglio dei Dieci, la massima assise dello Stato veneto, affrontò il problema incaricando una speciale Giunta delle Spezie (Additio Specierum) formata da quindici membri di trovare rimedi e soluzioni. Preoccupati e indecisi i saggi cercarono in un primo momento una mediazione con il sultano d’Egitto e inviarono, imponendo la massima segretezza, l’ambasciatore, Benedetto Sanudo con precise istruzioni: “Che mandi soi abassadori a queli Signori de India… fazendo ogni instantia cum dicti Signori che dicti portogexi non siano acceptadi”, ed inoltre “che le spetie se reducesseno alli pretij che solevano valer li anni avanti“.
La missione di Sanaudo non ebbe evidentemente successo poiché, nel febbraio 1504, accadde un fatto sconvolgente: per la prima volta le galee tornarono dal Levante con le stive vuote. Il traffico delle spezie aveva ormai preso nuove strade. A Lisbona re Manoel, con l’aiuto determinante di Jacob Fugger – il ricchissimo banchiere tedesco sino ad allora distributore del pepe veneziano oltre le Alpi – era riuscito ad ottimizzare i carichi delle spedizioni e organizzare una efficiente rete di vendita: tramite le strutture dei soci germanici, una volta arrivate, le spezie – acquistate all’origine e quindi libere da innumerevoli dazi e tributi – venivano trasportate dal Tago alla Schelda, da Lisbona ad Anversa dove Fugger aveva i fondaci, e da lì ripartivano per i mercati di tutta Europa. Con prezzi inferiori rispetto a quelli fissati dai mercanti di Rialto.
Dalle Fiandre le navi del tedesco ripartivano poi con carichi di argento e rame (ricavati dalle sue miniere austriache) verso il Portogallo, da dove venivano trasbordate sulle caracche dirette in India.
Per Venezia un disastro finanziario e politico. Ma, a differenza delle graziose quanto deboli signorie padane e della ierocrazia romana – Napoli e la Sicilia orbitavano da tempo nei panorami francesi o spagnoli – il governo dogale, forte di un’aristocrazia capace di pensieri lunghi e di un ceto mercantile pragmatico e, per molti aspetti, già moderno, conservava lucidità ed esprimeva volontà di potenza.
Il 9 marzo il Consiglio dei Dieci e la Giunta delle Spezie inviarono due emissari – Leopoldo da Ca’ Masse e Francesco Teldi, poi sostituito da Bernardino Giova – a Lisbona e al Cairo. Nelle bozze delle istruzioni al Giova i patrizi inserirono un passaggio cruciale. L’ambasciatore doveva suggerire al sultano, in modo assolutamente discreto, ufficioso e non ufficiale, un primo progetto – tre secoli e mezzo prima dell’apertura del Canale nel 1869 – di un taglio dell’istmo di Suez: “Far una cava dal Mar Roso che mettesse a drectura in questo mare de qua, come altre volte fo rasnado de far“. È interessante notare che si ipotizzava un canale a drectura, ovvero di un collegamento diretto e non del riutilizzo dell’antica idrovia attiva in epoca faraonica e romana, e di qualcosa di cui altre volte si discusso. Quindi, tutto fa supporre che i governanti avessero elaborato almeno una bozza di un progetto innovativo quanto riservato.
Ma, proprio alla vigilia della sua partenza, il Giova fu riconvocato d’urgenza dai paludati saggi e l’iniziativa annullata. Nel 1506-07 il dogato preferì fornire al Cairo tecnici e moderne artiglierie navali da utilizzare nell’Oceano Indiano contro le squadre di Lisbona – una guerra per procura, durissima quanto segreta a fianco degli “infedeli” contro i “cristianissimi” concorrenti… – e nel 1512 rinnovò un trattato commerciale sperando d’intercettare parte dei traffici dall’Oriente. I turchi, dal 1517 nuovi padroni dell’Egitto, distrussero a Gedda, sul Mar Rosso, la flotta lusitana; la vittoria alleggerì la morsa portoghese sui commerci consentendo ai veneti una settantina d’anni di ripresa economica.
Gli ottomani si posero a loro volta il problema del passaggio tra i due mari e agirono. Con convinzione ma senza risultati. Come riportano nei loro diari i viaggiatori (o agenti segreti veneziani? Non lo sappiamo…) Alvise Roncignotto e Filippo Pigafetta, tra il Cinquecento e il Seicento, i sovrani di Costantinopoli cercarono a più riprese di scavare l’istmo di Suez. Nel 1529 Roncignotto segnalò al governo dogale che Pargali Ibrahim Pascià, gran vizir di Solimano il Magnifico, aveva dato inizio agli scavi e in un altro viaggio, tra il 1532 e il 1533, vide circa 12mila uomini al lavoro. Con la tragica morte di Ibrahim, giustiziato dal sospettoso sultano nel 1536, il progetto venne sospeso, ma non accantonato. Nella sua relazione del 1576 il vicentino Pigafetta – parente di Antonio, l’avventuroso compagno e biografo di Magellano – accennò al successivo tentativo di Sinàm Bassà, ammiraglio del sultano Selim: “Di scavare una gran fossa a fine di condurre più lesto, et con più corta strada le artiglierie, i legnami, le munitioni da guerra, et le altre cose al Suez, né prima (come hora si fa) scaricarle in Alessandria, et indi menarle al Cairo su per il fiume, al di là della terra al Suez”.
Tutto s’interruppe, secondo Pigafetta, apparentemente perché i turchi temettero – riprendendo la leggenda risalente all’incolpevole Aristotele – che le acque del Mar Rosso fossero superiori di circa dieci metri a quelle del Mediterraneo. Molto probabilmente per il vicentino si trattava – confutando così l’idea del dislivello – di una pietosa inventione dei turchi intimoriti invece dalle difficoltà tecniche e dagli enormi costi.
Ben documentata è invece l’ipotesi del taglio dell’Istmo immaginata pochi anni dopo da una figura romanzesca: El Ulug Alì, per i cristiani più semplicemente Uluccialì o Occhialì. Il personaggio è interessante. Il suo vero nome era Gian Dionigi Galeni ed era nato in Calabria attorno al 1519. La famiglia lo aveva destinato alla vita monacale quando fu catturato nell’ennesima scorreria barbaresca guidata da Khayr al-Din Barbarossa e messo al remo. Per convenienza o convinzione (chissà?) il ragazzo si convertì alla fede islamica ed entrò nelle grazie dei suoi padroni. Diventato musulmano, si diede alla guerra di corsa e fece una rapida carriera: generalissimo del pascialato d’Algeria, governatore di Tripoli e Tunisi, prese parte alla battaglia di Lepanto e fu tra i pochi comandanti della flotta turca a sopravvivere. Per aver conquistato nello scontro lo stendardo dei Cavalieri di Malta, Selim II lo nominò kapudan, supremo Ammiraglio del mare, con il difficile compito di ricostruire, all’indomani della sconfitta, la marina sultaniale. Dopo molte imprese, culminate nel 1587 con una vittoria contro gli spagnoli e la riconquista di Tunisi, l’avventuroso corsaro morì nel luglio del 1587 in un villaggio nei pressi di Costantinopoli. Ai suoi schiavi lasciò i beni di proprietà, compreso un villaggio da lui fondato e chiamato Nova Calavria.
La fama del personaggio era tale che nel luglio del 1586 l’ambasciatore francese sul Bosforo, Savary de Lancosme, scrisse allarmato al re Enrico III di una visita di El Ulug Alì in Egitto. Secondo il diplomatico, l’ammiraglio si era recato sul Nilo per verificare la possibilità di: “Un’impresa impossibile, cioè di aprire un canale dal Cairo ad una città che si chiama Suez sulla punta del golfo del Mar Rosso”. Nella missiva si fornivano altri particolari sulle modalità del progetto che, secondo le voci raccolte, necessitava l’impiego di centomila uomini, quarantamila asini e dodicimila cammelli. La missione del rinnegato calabrese non era sfuggita nemmeno all’inviato veneziano Lorenzo Bernardo che subitamente avvertì il doge, affermando che gli ottomani: “Sono entrati in opinione che non vi sia altro rimedio, che ricavar quell’alveo che altre volte dai re d’Egitto era stato fatto, il quale incominciando dal porto di Damiata, traversando per 150 miglia incirca di paese, passava nel Mar Rosso al porto di Suez, pel quale comodamente si possa condur galee da questo in quel mare e con facilità”.
Il governo marciano – per una volta tanto in sintonia con Roma – informò prontamente papa Sisto V, ma il pontefice non si preoccupò particolarmente. Come riferiscono i rapporti dell’ambasciatore veneziano presso la Santa Sede, il Papa, convinto dai suoi esperti del dislivello tra i due mari, si tranquillizzò, ringraziò il diplomatico e si disinteressò della questione. Sisto non aveva tutti i torti, poiché il sultano – defunto El Ulug Alì – abbandonò per sempre il dispendioso progetto.