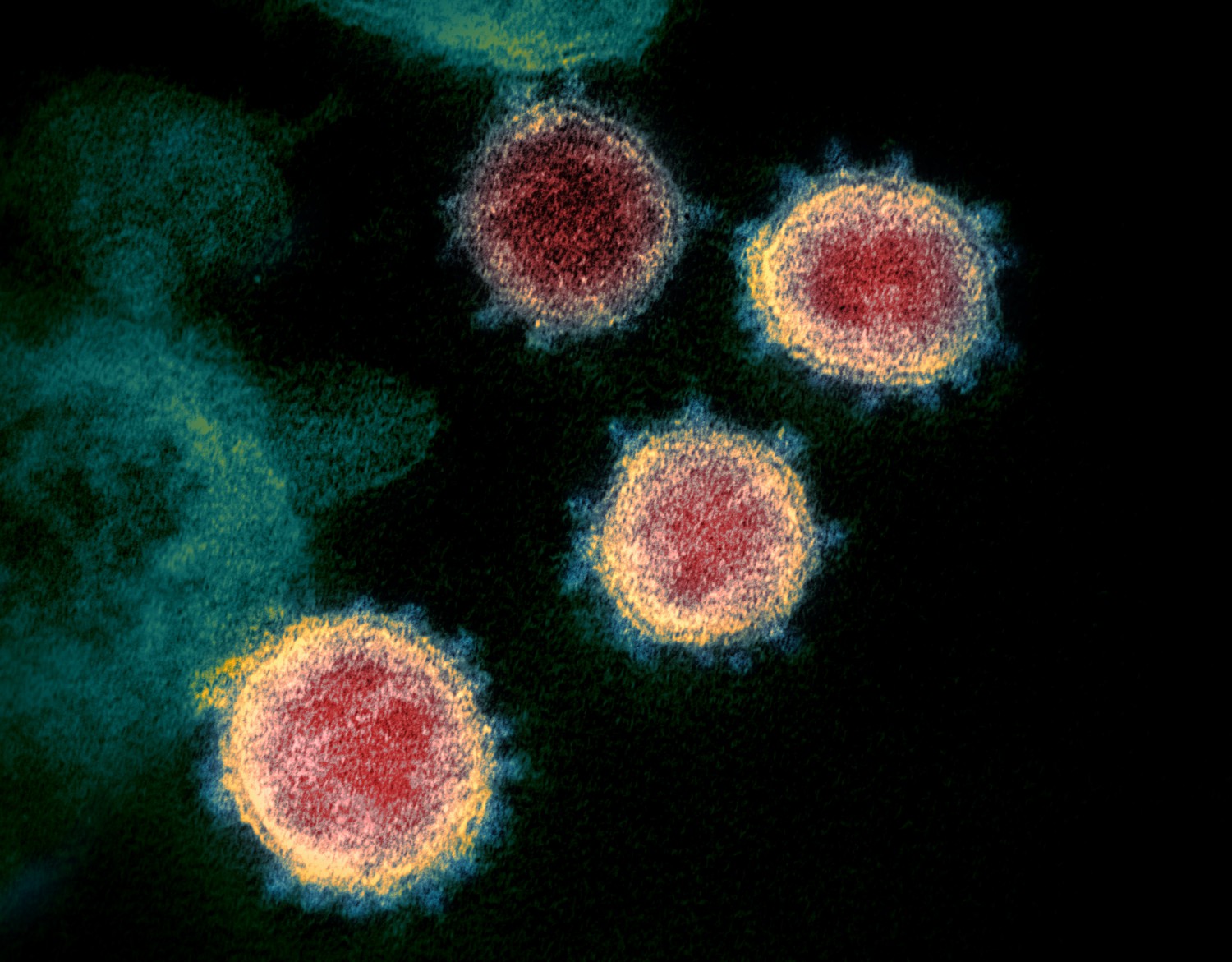L’attuale pandemia da coronavirus Covid-19 ha fatto riemergere nell’uomo l’atavico timore delle malattie infettive, che, forse troppo sbrigativamente, è andato dimenticato soprattutto in Occidente. Al netto delle origini dell’attuale malattia, ovvero dei meccanismi che hanno permesso il salto di specie da animale a uomo al virus diffusosi a partire dalla Cina, è interessante cercare di capire se le epidemie che hanno accompagnato la storia umana recente siano più frequenti rispetto al passato e per quale motivo.
Prima di addentrarci nella trattazione diventa però interessante fornire qualche cenno di carattere scientifico che ci permetterà di trarre delle conclusioni che non siano esclusivamente basate sulle cronache degli ultimi cento anni di storia dell’umanità.
Il primo ad affrontare il tema della “storia delle epidemie” è stato lo storico francese Mirko Grmek che alla fine degli anni ’60 del secolo scorso ha proposto di leggere in chiave ecologico-evolutiva le trasformazioni che hanno subito le malattie, soprattutto quelle infettive, che nelle diverse epoche hanno colpito l’uomo. Utilizzando come modello la nozione di biocenosi, che nell’ecologia definisce l’insieme di tutti gli organismi presenti in un ecosistema, Grmek ha proposto il concetto di patocenosi, inteso come l’insieme di stati patologici presenti all’interno di una data popolazione in un determinato momento.
Più in dettaglio la patocenosi si articola su tre punti fondamentali: l’insieme degli stati patologici presenti in una determinata popolazione a un momento storico dato; il principio secondo cui la frequenza e la distribuzione di ogni malattia dipendono, oltre che dai fattori endogeni ed ecologici, dalla frequenza e dalla distribuzione di tutte le altre malattie che possono ostacolare, favorire o essere indifferenti nella diffusione; infine il principio che la patocenosi tende verso uno stato di equilibrio, in particolare in una situazione ecologica stabile.
Avendo in testa questo principio risulta interessante dare uno sguardo alla storia dell’uomo sin dai suoi albori. I nostri antenati ominidi avevano diversi “patogeni di famiglia”, cioè parassiti, condivisi con gli antenati dell’ordine dei primati, come pulci, vermi, protozoi, enterobatteri, stafilococchi e streptococchi. Le punture di insetti, i morsi di animali, la lavorazione e il consumo di cibo contaminato sono stati all’origine di zoonosi come tubercolosi, leptospirosi, schistosomiasi, tetano, tripanosmiasi e trichinosi. Fintanto che l’uomo aveva una vita ed una società articolate sull’essere cacciatore/raccoglitore alcuni patogeni, come il morbillo o il vaiolo, non riuscivano a trovare terreno fertile e a diventare quindi endemici nella popolazione.
Il passaggio da un’economia di caccia e raccolta a una basata sull’agricoltura ha però stravolto l’equilibrio. Questo importantissimo cambiamento, anche conseguente ai cambiamenti climatici cominciati 18mila anni fa quando avvenne quello che in geologia si chiama Lgm (Last Glaciation Maximum), ha modificato non solo la nostra società ma anche la nostra biologia.
La transizione all’agricoltura e l’addomesticamento e allevamento degli animali espongono l’uomo a nuovi agenti infettivi, e a nuove cause di malattia anche non trasmissibili, modificando quindi per la prima volta nella storia dell’umanità la nostra patocenosi. Gli insediamenti umani costituiscono una nuova nicchia ecologica per gli agenti patogeni per tutta una serie di motivi che spazia dall’aumento della densità di popolazione, all’impatto delle coltivazioni e degli allevamenti sull’ecosistema. Inoltre l’economia agricola primordiale non dava il corretto apporto energetico all’uomo rendendolo debole e quindi più esposto ai contagi di malattie infettive anche in considerazione della mutata biocenosi data dagli insediamenti urbani con insetti e roditori che hanno cominciato a vivere “in simbiosi” con le nostre città e villaggi.
Grazie agli allevamenti e agli animali domestici poi, decine di malattie effettuano il salto di specie e si diffondono nell’uomo proprio a partire dal 6000 a.C. Tra di essi si ricordano: scabbia, morbillo, vaiolo, tubercolosi, carbonchio, influenza e la terribile peste.
La rapida urbanizzazione conseguente al nascere di civiltà ed imperi ha accelerato questo fenomeno tanto che le prime società organizzate del Medio Oriente, dell’Egitto e dell’Asia (sud-est e centrale) acquisiscono ognuna una distinta serie di malattie infettive, ma soprattutto, ed è il fattore più interessante, quando tra queste si stabiliscono i primi contatti, si creano le condizioni per la nascita di gravi epidemie, soprattutto nel caso di campagne di conquista o guerre, quando si scontrano le diverse patocenosi.
Insomma già nell’antichità l’uomo doveva fare i conti con pestilenze ed epidemie, e uno studio condotto su testi greci che raccolgono casi di malattie ha mostrato che i tipi e le proporzioni tra esse presenti in quel tempo sono già grosso modo quelli che caratterizzeranno la storia dell’Europa fino alla metà del diciannovesimo secolo. Esistono chiaramente delle differenze: per esempio il morbillo, la rosolia e diverse malattie virali che caratterizzano l’età moderna sono assenti nell’antichità, così come la sifilide, il vaiolo, la lebbra, il colera e soprattutto l’influenza.
Quello che è importante sottolineare è che con l’intensificarsi di viaggi e guerre tra civiltà contigue dell’Eurasia, le malattie infettive che hanno origine nell’Asia cominciano a diffondersi ma ancora a fasi alterne che, non casualmente, dipendono dalla storia degli imperi: dalla metà del quinto secolo d.C. gli scambi commerciali in Europa diminuiscono e le grandi città cominciano a spopolarsi con l’arrivo dei popoli invasori, che portano nuove malattie ma che troveranno meno terreno fertile proprio perché la società urbana era in crisi.
Fino al sesto secolo, infatti, ci sono meno epidemie, ma a partire dal 541 ricompare in Europa il vaiolo, e nel 542 per la prima volta le peste bubbonica, che da Costantinopoli, dove è arrivata dal Mar Rosso, giunge a Roma nel 543. Circa 20 ondate si susseguono dal 541 al 767, quanto la malattia scompare sia dall’Europa che dall’Asia e dall’Africa.
Malattie e carestie, dipendenti da fattori esterni come cambiamenti climatici o strutturali come il rinascere delle città nell’epoca comunale, hanno continuato ad accompagnare l’umanità sino ad arrivare a quella che è forse la pestilenza più conosciuta in Europa: la peste nera che ha devastato un intero continente dal 1347 al 1352, sterminando tra il 25 e il 50% della popolazione e portando con sé grandi cambiamenti nell’economia, nella geopolitica e anche nella religione.
Peste che ritornerà, famosissima essendo stata consegnata alla letteratura da Alessandro Manzoni, quasi tre secoli dopo tra il 1629 ed il 1633, e che, solo in Italia settentrionale, si stima che uccise un milione e centomila persone su 4 milioni di abitanti.
Era un mondo molto diverso, ma la corsa della malattia, che in cinque anni, nel quattordicesimo secolo, fece il giro d’Europa, sarebbe stata sicuramente più lenta se la società fosse stata ancora quella primitiva, ovvero senza quella frequenza di scambi commerciali che la caratterizzavano.
Oggi le malattie infatti corrono, anche grazie al tipo di società in cui viviamo caratterizzato da grandi assembramenti di popolazione nelle città. Venendo a tempi recenti e limitandoci alle pandemie influenzali del ventesimo secolo, possiamo vedere come ci sia una differenza di velocità e maggiore diffusione spaziale delle epidemie rispetto ai secoli scorsi: la “spagnola”, uccise tra i 50 e i 100 milioni di persone in due anni, tra il 1918 e 1919, portata in giro per il mondo dai soldati che rientravano in Patria dopo la Prima Guerra Mondiale; la “asiatica”, nata forse a Singapore, uccise due milioni di persone in un periodo più o meno simile tra il 1957 e il 1958; l’influenza di Hong Kong nel 1968 uccise tra le 750mila ed i 2 milioni di persone nell’arco di un anno, infine la Sars e la Mers si sono diffuse in pochissime mesi ma sono state contenute grazie ad efficaci politiche sanitarie. Anche l’attuale pandemia di coronavirus ha fatto il giro del mondo in pochissime settimane.
Le cause di questa rapidità nella diffusione sono molteplici ma principalmente possono essere ridotte a due: la prima di carattere sociale causata da un sentimento di falsa sicurezza tecnologica, la seconda data dalla globalizzazione spinta e dallo stesso progresso che ci permette di viaggiare da una parte all’altra del globo in poche ore.
Per quanto riguarda quella che è stata chiamata “illusione tecnologica”, possiamo dire, riassumendo, che l’avvento dei vaccini, il progresso della scienza medica dai tempi di Jenner passando per Pasteur e la genetica, ma soprattutto l’eradicazione del vaiolo ha diffuso un falso sentimento di sicurezza non solo tra la popolazione, ma anche tra i vertici scientifici: alla fine degli anni sessanta l’Oms organizzava delle riunioni di esperti ponendo domande del tipo “le malattie infettive sono ancora importanti?” ed anche se la risposta era stata positiva il fatto stesso che la domanda fosse stata posta mostra la prevalente atmosfera di ottimismo.
La globalizzazione ha poi un ruolo fondamentale, anche se duplice: se da un lato lo sviluppo ed implementazione delle relazioni internazionali e quindi lo scambio e la condivisione di informazioni di tipo medico grazie alla stipula di apposite convenzioni sanitarie internazionali e all’organizzazione di congressi e riunioni scientifiche, ha permesso di affrontare le malattie in modo uniforme mettendo a sistema le eccellenze dei singoli Stati, dall’altro la stessa società globalizzata ha permesso alle patologie di “correre” ben al di là della loro patocenosi e diffondersi molto più rapidamente rispetto al passato.
Del resto se oggi per fare da Pechino a Roma bastano poco più di 17 ore di volo, cento anni fa ci sarebbero volute settimane, e trecento anni fa il viaggio avrebbe richiesto mesi: una malattia, a seconda della virulenza, avrebbe quindi potuto fermarsi molto prima della destinazione uccidendone il portatore o dandogli tempo di guarire.
Quindi, per rispondere alla domanda di partenza, forse le epidemie non sono più frequenti rispetto al passato se le guardiamo dal punto di vista dell’intera umanità, ma si muovono più velocemente e quindi arrivano con più facilità in tutti i punti del globo rispetto solamente ad un secolo fa.