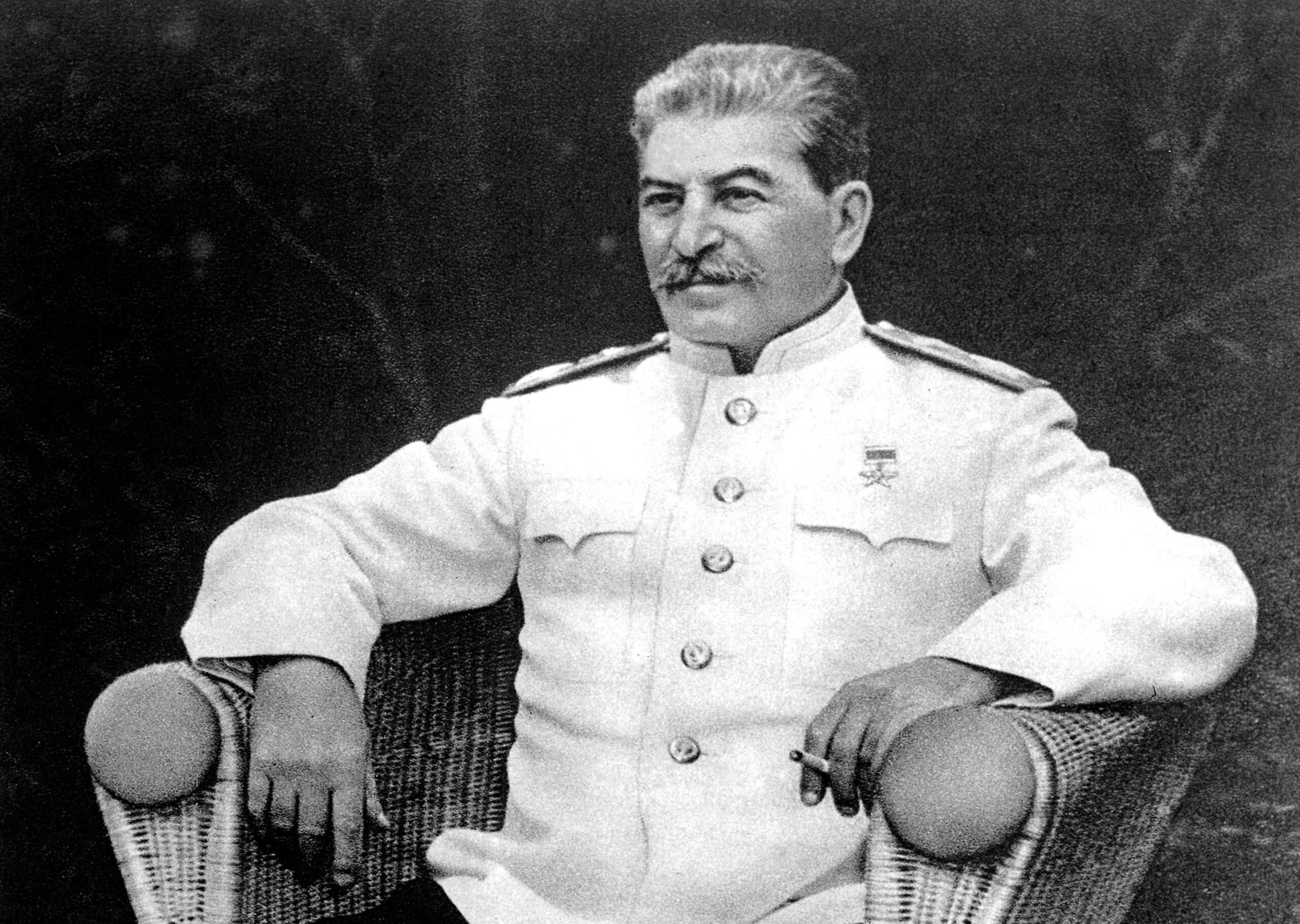I nomi dei campi di concentramento del cosiddetto “Arcipelago Gulag”, l’universo concentrazionario costruito in Unone Sovietica, ramificatosi ai tempi di Stalin e definito in questa maniera nell’emblematica opera di Aleksandr Solženicyn, sono molto meno noti nella memoria collettiva europea rispetto alle fabbriche della morte della Germania nazista, così come spesso è capitato che minore attenzione sia stata data a crimini del regime stalinista come l’Holodomor, la grande carestia ucraina indotta dal potere sovietico tra il 1932 e il 1933, e l’eccidio di Katyn contro i prigionieri polacchi nel 1940.
Ma quella dei Gulag è una storia che va conosciuta e raccontata, per capire la portata della repressione esterna e interna che l’Unione Sovietica di Stalin impose tra gli Anni Trenta e Cinquanta e ricostruire volti, storie e vite di coloro che furono inghiottiti dai campi di lavoro nell’Oriente russo e in Siberia. L’arcipelago dei gulag non fu costruito con espliciti intenti sterminatori come accaduto in alcuni campi di concentramento nazisti, ma reclamò un tributo di milioni di vittime morte per stenti, freddo, sfinimento o per mano delle guardie sovietiche. Poche storie spiegano bene cosa fu per milioni di cittadini sovietici il mondo dei gulag quanto quella del più famoso dei campi che furono strutturati in era staliniana: quello vicino alla città di Vorkuta.
Quella di Vorkuta, cittadina mineraria della Repubblica di Komi, nel Nord-Est subartico della Russia, è una storia che inizia pochi anni prima di quella di Vorkutlag, il campo di lavoro cui la storia della città è tragicamente associata.
Nel 1930 il geologo sovietico Georgy Chernov scoprì consistenti giacimenti di carbone vicino al fiume Vorkuta, a 1.200 km a Nord di Mosca e solo 100 km a sud del Circolo polare artico, poco distante dal bacino di Pechora che era stato scoperto dal padre Alexander a inizio secolo. Questo segnò l’inizio della corsa mineraria nella Repubblica di Komi, ai tempi soggetto federale della Russia sovietica. Nel 1931 il paese di Vorkuta, che prendeva il nome dal fiume e che nel 1943 sarebbe stato proclamato città a sé, prese forma attorno all’insediamento di geologi e minatori intenti a scoprire le nuove risorse minerarie ritenute strategiche dall’industria pesante di Mosca.
L’universo concentrazionario sovietico stava già presidiando quelle terre puntando sul campo di Ukhta-Pechora, ma dal 1932 sorse la necessità di un presidio più diretto per fornire manodopera forzata e a basso costo. Nacque dunque l’insediamento di Vorkuta controllato direttamente dalla Ogpu, la polizia sovietica di stampo segreto che dal 1934 avrebbe preso il celebre nome di Nkvd sotto la guida del rigido Lavrenti Berija.
Vorkuta fu pensato non solo come hub per lo sfruttamento del lavoro dei detenuti ordinari nel sistema concentrazionario, ma anche come vera e propria capitale della repressione. Dal 1932 in avanti Stalin avviò con forza la campagna di repressione della dissidenza in Ucraina, rafforzò le deportazioni dei kulaki nel quadro della campagna di collettivizzazione, iniziò a ordinare lo spostamento interno all’Urss di popoli ritenuti potenziali quinte colonne di potenze straniere, portando ad esempio i coreani dell’Estremo Oriente in Kazakistan, scatenò infine tra il 1937 e il 1938 le “Grandi Purghe” contro i suoi avversari nel Partito Comunista dell’Unione Sovietica. Tutti questi processi alimentarono un flusso incessante di deportati condotti nell’arcipelago gulag, che iniziò ad acquisire funzioni di repressione e annientamento della dissidenza.
Vorkuta crebbe nel corso degli anni fino a diventare il centro di un sistema di 132 sottocampi centrati su Vorkutlag, in cui nel corso della seconda guerra mondiale erano detenuti stabilmente tra i 60 e i 70mila prigionieri. Negli anni, sarebbe diventata la destinazione dei prigionieri di guerra polacchi e tedeschi prima e dei comunisti dissidenti trovati nei Paesi liberati dall’Armata Rossa nella seconda guerra mondiale poi.
Il carbone, da elemento chiave per l’industrializzazione, divenne anche strumento di morte. A Vorkuta, nel gulag più famoso assieme a quello della Kolyma, tra il 1932 e il 1956 lavorarono e morirono cittadini di 47 nazionalità diverse per tirare fuori dalla terra quel carbone necessario ai piani quinquennali sovietici.
“Stalin voleva dimostrare che i comunisti possono tutto, perfino produrre qualcosa in un ambiente impossibile dove d’inverno le temperature scendono a -55 gradi, le ore di luce si riducono a due e la tundra è avara per chi la vuole coltivare”, ha dichiarato nel 2019 il geologo russo Alexander Kalmykov, segnalando le durissime condizioni di quella che coi dati attuali a disposizione è ritenuta la città più fredda d’Europa.
L’esposizione al lavoro, la durezza delle condizioni di vita, l’assenza di trattamenti sanitari adeguati e lo sfinimento furono la causa della morte di circa un decimo dei due milioni di detenuti che passarono attraverso le baracche e i campi di Vorkuta. Duecentomila morti pagati come tributo al sogno di purificazione sociale di Stalin, in un massacro iniziato alle prime fasi della storia del campo: della prima spedizione di 1.500 prigionieri inviati a Vorkutlag ne sopravvissero solo 84.
Inizialmente i condannati al gulag dovevano raccogliere il carbone a mani nude, tuffandosi nelle viscere di una terra spesso insicura, in miniere prive di ogni standard securitario. Il lavoro come strumento di morte, in barba allo slogan che i detenuti trovavano all’ingresso di Vorkutlag secondo cui stavano contribuendo alla “gloria del socialismo“. Nel 1938 Vorkuta era divenuto, con 15mila detenuti, un insediamento in grado di produrre in forma più strutturata 188mila tonnellate di carbone appoggiandosi su una serie di centri dispersi su un’area più grande di quella dell’Irlanda a ridosso del 67° parallelo Nord.
Come ricordato da un reportage di New Lines Magazine “la fuga era impossibile”, tanto che attorno ai campi non c’era alcun reticolato di filo spinato o altra struttura di guardia: come pensare di sopravvivere nel quadro della regione più inospitale della Russia, in caso di fuga, senza alcun appoggio con altri esseri umani?
L’alternativa era dunque da scegliere senza sconti: contribuire all’estrazione mineraria nei bacini di Pechora e Vorkuta, che nel 1942 “conobbero il loro apice dopo che i tedeschi occuparono il Donbass” con i suoi preziosi giacimenti trasformando “la regione nella maggiore garante della sicurezza energetica di una nazione in guerra affamata di carbone.
Il carbone, per inciso, è ancora oggi la principale fonte di sostentamento di una città che vede ancora tre campi attivi, il più profondo dei quali arriva a 1.100 metri sotto terra. Nel periodo della seconda guerra mondiale, i prigionieri lavoravano a un numero di strutture molto più ampio, andando incontro a incidenti e rischi. Il fatto stesso che nel cuore delle fabbriche della morte sovietiche nel 1944 l’orario di lavoro venisse abbassato da 12 a 10 ore al giorno segnala la drammaticità della condizione in cui i prigionieri erano costretti a operare.
La fine della seconda guerra mondiale non segnò la fine di Vorkutlag. Esso restò pienamente operativo fino alla fine dell’era di Stalin, che morì nel 1953 quando preparava nuove purghe, nuove repressioni e nuove palingenesi dopo la rottura con l’ex alleato Tito.
La scomparsa del dittatore aprì nei detenuti speranze di una pronta liberazione presto deluse. Come ebbe a scrivere Solženicyn nel suo lavoro più celebre “La differenza [dei lager di Chruščёv] coi lager di Stalin non è data dal regime di detenzione, bensì dalla composizione degli effettivi: non ci sono più milioni e milioni di Cinquantotto”, i detenuti segnalati per reati controrivoluzionari. “Ma, come prima, i detenuti si contano a milioni e, come prima, molti sono esseri senza difesa, vittime di una giustizia iniqua e cacciati nei lager unicamente perché il sistema vuole sopravvivere ad ed essi rappresentano il suo nutrimento”. Nel luglio 1953, una rivolta di detenuti si concluse con la repressione delle guardie sovietiche e almeno cinquantatre morti, tra cui il prete cattolico lettone Jānis Mendriks, oggi venerato come Servo di Dio.
Nove anni dopo, nel 1962, l’era di Vorkuta finì. Mano a mano che le pene dei detenuti sopravvissuti finivano, essi tornavano a essere liberi cittadini sottoposti però al regime di confinamento vicino al campo dove erano stati tenuti per lunghi anni, spesso decenni. Il campo fu liquidato dal Ministero dell’Interno sovietico e di esso oggi non resta praticamente più nulla, se non il ricordo. A Vorkuta si può scendere nelle miniere abbandonate, vagare tra resti di prefabbricati sfasciati e entrare nelle pochissime costruzioni integre, completamente saccheggiate. E mentre anche in Russia si immagina il graduale superamento dell’industria del carbone, appare sempre più plausibile pensare che anche Vorkuta potrà in futuro cessare definitivamente la sua attività. In futuro, dunque, il territorio che fu testimone della più dura forma di repressione del regime staliniano potrebbe tornare nel dominio dei ghiacci che lo avvolgono nove o dieci mesi l’anno. Muti testimoni di una storia tragica di cui è, ora più che mai, fondamentale mantenere il vivo ricordo.