Neo-ottomanesimo è indubbiamente uno dei termini più in voga del momento tra i politologi occidentali. Questo concetto sta venendo erroneamente impiegato per descrivere la politica estera particolarmente assertiva e muscolare della Turchia nei Balcani, nel Mediterraneo orientale, nella regione Medio Oriente e Nord Africa, nel Caucaso e in Asia centrale, e induce in errore chiunque ne faccia uso per una ragione molto semplice: l’impianto ideologico che guida le azioni di Recep Tayyip Erdogan è molto più complesso, ricco e profondo.
Non è con il neo-ottomanesimo, ad esempio, che si può comprendere e spiegare l’inusuale sodalizio tra Ankara, aspirante potenza-guida del mondo musulmano e legittima erede dell’impero ottomano, e Budapest, che Fidesz sta tentando di riportare ai fasti dell’era austro-ungarica; la chiave di lettura è il turanismo. Neanche il protagonismo turco nel Nagorno Karabakh può essere capito pienamente rifacendosi al pensiero neo-ottomano, sebbene sia quella la direzione che stanno prediligendo la grande stampa e gli stessi scienziati politici. È stato lo stesso Mevlut Cavusoglu, il ministro degli esteri turco, a illustrare le ragioni dell’intervento all’indomani dell’apertura delle ostilità, condensandole nella frase “una nazione, due Paesi”; in altre parole, panturchismo.
Non si può, infine, fare esclusivamente ricorso al neo-ottomanesimo per leggere il braccio di ferro greco-turco nell’Egeo e nel Mediterraneo Orientale. In quell’area estremamente calda dell’Europa allargata entrano in gioco elementi meno ideologici e più pragmatici, ossia le dottrine di sicurezza nazionale elaborate da forze armate, la Patria Blu (Mavi Vatan), e diplomazia, la Zero Problemi con i Vicini (Komşularla Sıfır Sorun Politikası).
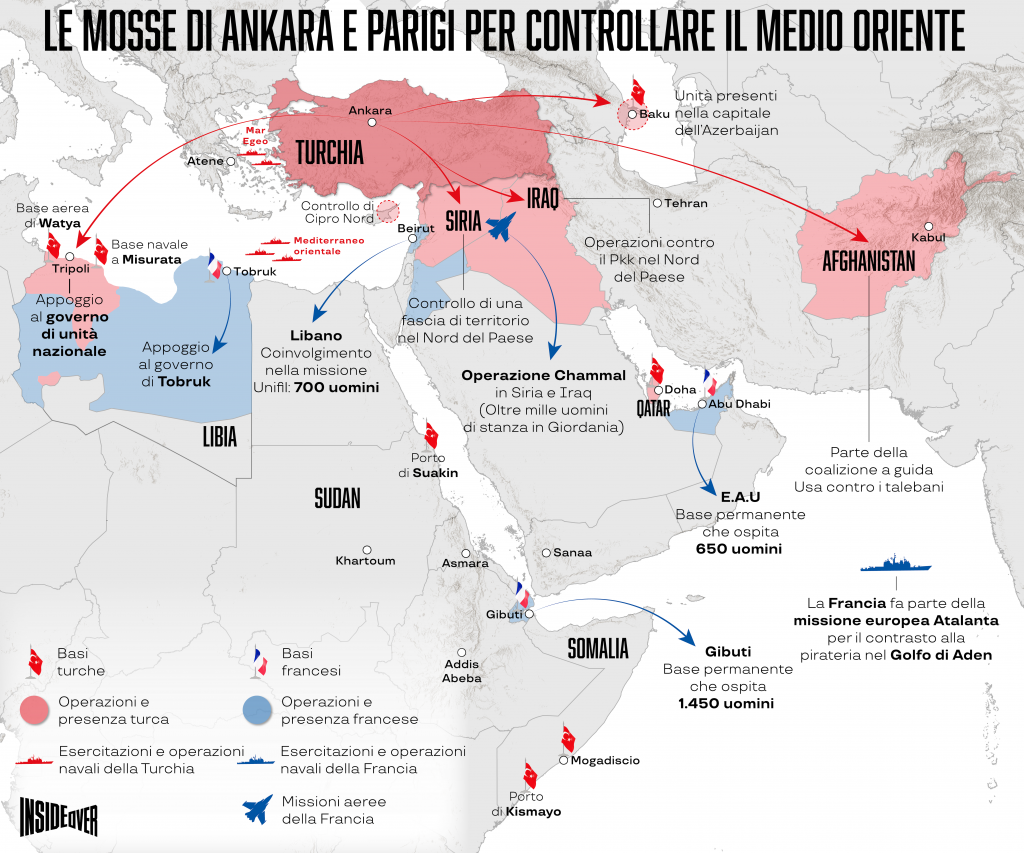
Al di là di queste puntualizzazioni necessarie è innegabile la centralità del neo-ottomanesimo nell’agenda estera di Ankara, la cui pressione è in particolar modo palpabile nel Vecchio Continente, e questo è il motivo per cui occorre una disamina del suo progenitore, Necmettin Erbakan. Passato alla storia come l’ultimo primo ministro turco ad essere detronizzato dalle forze armate, poiché ritenuto una minaccia per l’integrità delle istituzioni kemaliste, meno noto è che fu anche il mentore di Erdogan. Non si può capire la Turchia degli anni 2010 e 2020 senza recuperare dal dimenticatoio questo capitolo di storia.
Erbakan nacque a Sinop (Turchia settentrionale) il 29 ottobre 1926 da una piccola famiglia aristocratica appartenente all’antica tribù degli Afshari. Formatosi come ingegnere, professione per la quale ottenne una laurea all’università tecnica di Istanbul e un dottorato presso la prestigiosa università di tecnica di Aquisgrana, non mostrò interesse per la politica fino alla seconda metà degli anni ’60.
È possibile ed è materia di dibattito che un ruolo-chiave nello spostamento delle sue priorità carrieristiche ed esistenziali sia stato giocato proprio dal soggiorno pluriennale in Germania, dove ebbe modo di entrare in contatto con i primi connazionali della piccola ma crescente diaspora. Erbakan, disinteressato alla politica ma non alla religione, vide nel modello Germania Ovest una chimera che avrebbe potuto spoliare l’identità dapprima dei turchi espatriati e, poi, di quelli anatolici, essendo la Turchia stata inserita in un percorso di occidentalizzazione, tanto geopolitica quanto culturale, a partire dall’era Ataturk.
Erbakan fece ritorno in patria come un uomo radicalmente cambiato. Nel 1965 realizzò il sogno della vita: ottenere la cattedra in ingegneria presso l’università tecnica di Istanbul, ma abbandonò la posizione quattro anni più tardi per dedicarsi alla politica. Riuscì a entrare in Parlamento come candidato indipendente, eletto con i voti della città di Konya e, nello stesso periodo, iniziò a frequentare la scuola sufi di İskenderpaşa (İskenderpaşa Cemaati), una comunità chiusa la cui origine risale alle ultime fasi di vita dell’impero ottomano e che dal dopo-Ataturk stava impegnandosi nell’arduo compito di preservare l’islam dalla soppressione delle istituzioni kemaliste.
Nelle aule di quella scuola, alcuni anni più tardi, sarebbe entrato anche un altro futuro protagonista della politica: il giovane Erdogan.
Il 1969 fu l’anno della svolta per Erbakan: entrò ufficialmente in politica e condensò le sue idee per il futuro della Turchia in un manifesto politico intitolato “Visione Nazionale” (Millî Görüş). Da quel pamphlet nacque anche un movimento politico, al quale fu dato lo stesso nome, avente come obiettivo la restaurazione dei valori islamici nella società, nella cultura e nella politica.
Dal ventre fertile di Milli Gorus si originarono una serie di iniziative travolgenti, come l’invito del pugile di fama mondiale Muhammad Alì a Istanbul nel 1976 (evento organizzato da Erbakan in persona), di proposte coraggiose, come la riapertura di Santa Sofia a luogo di preghiera, e di partiti più o meno influenti, come Salvezza Nazionale (Millî Selâmet).
Fu in questo periodo di grande fermento culturale, risveglio del fervore religioso e agitazione popolare, che Erbakan incontrò un giovane militante, classe 1954, caratterizzato da un anticomunismo spasmodico e da una fede verace: Recep Tayyip Erdogan. Tra i due visionari fu simbiosi immediata: Erbakan vide in Erdogan il proprio erede, colui al quale affidare le redini della propria visione non appena i tempi sarebbero diventati maturi, come dimostrato dalla sua repentina scalata al vertice di Salvezza Nazionale.
Il carisma di Erbakan giocò un ruolo-chiave nel permettere a Salvezza Nazionale di conseguire un risultato inaspettatamente positivo alle elezioni generali del 1973 (11,8% dei voti), che gli consentì di entrare dapprima in Parlamento e, poi, nel governo come parte di una coalizione con il Partito Popolare Repubblicano.
Una volta al potere Salvezza Nazionale avrebbe dato inizio ad una lenta infiltrazione dei gangli dell’apparato della sicurezza, mettendo in allarme le forze armate e i servizi segreti e determinandone l’intervento nel 1980; la curiosa esperienza della coalizione formata dal partito kemalista per antonomasia e da un partito islamista ebbe vita breve. I militari rimasero al potere fino al 1983, depurando ogni settore e ramo istituzionale presumibilmente caduto delle mire espansionistiche di Erbakan. Quest’ultimo fu messo temporaneamente al bando dalle attività politiche, mentre Salvezza Nazionale fu dissolto.
Sul finire della guerra fredda Erbakan fondò una nuova forza politica, il Partito del Benessere (Refah Partisi), con la quale si presentò alle elezioni generali del 1995 e ottenne un risultato straordinario: prima posizione, con il 21,38% delle preferenze. La differenza rispetto al 1973 era di sostanza, nel senso che la visione di Erbakan si era arricchita di una serie di elementi che, in Occidente, le sarebbero valsi il titolo di “neo-ottomanesimo”.
Il Partito di Salvezza Nazionale, come intuibile dal nome, era guidato da un progetto di natura circoscritta, destinato ad agire entro l’Anatolia e la Tracia orientale; il Partito del Benessere, invece, aveva elaborato anche una propria politica estera, completamente innovativa e suscettibile di produrre un terremoto nelle relazioni internazionali.
Erbakan, che si insediò a capo del consiglio dei ministri nel 1996, avrebbe voluto trasportare la Turchia al di fuori della sfera di influenza occidentale, un posizionamento ritenuto anti-storico, e consacrarne il ritorno al passato, all’antico ruolo di paese-guida del mondo musulmano.
Un altro punto focale dell’agenda estera di Erbakan era l’ossessione per Israele: la Turchia, una volta unito il dar al-islam sotto la sua bandiera, avrebbe dovuto procedere alla conquista di Gerusalemme o, più precisamente, alla sua liberazione.
Ai fini dei punti di cui sopra, Erbakan diede vita all’Organizzazione per la Cooperazione Economica degli Otto in Via in Sviluppo (D-8 Organization for Economic Cooperation), anche conosciuta come D-8, riunente le principali economie emergenti del mondo musulmano: Iran, Malesia, Indonesia, Egitto, Bangladesh, Pakistan e Nigeria. Consapevole delle potenzialità offerte dai sistemi multilaterali di ispirazione funzionalista, come la Comunità Economica Europea, Erbakan vedeva nel D-8 il trampolino di lancio verso l’unificazione del dar al-islam.
Il suo ambizioso disegno ideologico e geopolitico – che, mai, fu definito “neo-ottomano” da Erbakan – naufragò a un anno dall’inizio dei lavori. Il punto di rottura con le forze armate fu una bilaterale con Muammar Gheddafi, durante la quale si discusse di creare un fronte pan-arabo in chiave anti-israeliana e, a latere, anti-occidentale.
Lo stato profondo attivò l’Ergenekon, l’equivalente turca delle Gladio europee, e il Gruppo di Studio Occidentale (Batı Çalışma Grubu), una lobby kemalista operante tra gli alti ranghi delle forze armate, che il 28 febbraio 1997 inviarono un ultimatum sotto forma di memorandum a Erbakan: fine dell’esecutivo o colpo di stato.
Il primo ministro comprese la gravità della situazione e rassegnò le dimissioni, mentre il Partito del Benessere fu dissolto dalla giustizia con l’accusa grave di aver minato la sicurezza nazionale per mezzo della promozione del fondamentalismo islamico. Erbakan fu fatto nuovamente oggetto di un divieto di svolgere attività politiche, che tentò di aggirare entrando a far parte del Partito della Virtù in qualità di consulente informale; il partito, però, fu dichiarato incostituzionale nel 2001 e quindi disciolto.
Consapevole che l’entrata nel neonato e promettente Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) ne avrebbe determinato la fine prematura per via delle pressioni dello stato profondo kemalista, Erbakan tentò di rientrare nell’arena politica con il Partito della Felicità ma senza conseguire alcun risultato di spessore.
Morì il 27 febbraio 2011 per un’insufficienza cardiaca lasciando un ultimo e curioso volere: un semplice funerale religioso in luogo di un funerale di stato; la sua richiesta, però, non fu accolta e fu allestito anche un ultimo saluto in forma civile. Ad ogni modo, il vero evento fu il funerale religioso, al quale parteciparono migliaia di fedeli e lo stesso Erdogan, che interruppe un tour in corso nell’Unione Europea per prendervi parte.
Erbakan è morto da quasi un decennio, ma la sua anima e il suo pensiero vivono e permeano la Turchia più che in passato. Erdogan, che è riuscito laddove il suo maestro ha fallito, ossia a distruggere lo stato profondo e a ricostruirlo ex novo, sta tentando di trasformare in realtà ogni paragrafo della “visione nazionale”, dalla de-occidentalizzazione delle masse (ri-nazionalizzate e re-islamizzate) alla costruzione di un ordine musulmano turco-centrico.
Non si possono comprendere pienamente alcune delle principali iniziative di politica estera dell’era Erdogan, come l’esercito dell’islam e il sodalizio con le potenze musulmane dell’Asia (in particolare Pakistan e Malesia), i riferimenti alla liberazione di Gerusalemme e la riconversione in moschea di Santa Sofia, trascurando il peso dello spettro di Erbakan, colui che per primo ha immaginato tutto ciò.
Lo stesso neo-ottomanesimo contemporaneo, inteso come recupero dell’identità imperiale e riposizionamento geopolitico in chiave antioccidentale e anti-israeliana, non è stato concepito dal duo Erdogan-Cavusoglu, ma da Erbakan.
Ma l’eredità più consistente del defunto primo ministro è stata sicuramente la riconquista delle diaspore stanziate in Europa, un’ossessione, per lui, sin dagli anni ’60. Una nazione capace di esercitare un richiamo ancestrale sui propri figli, ovunque essi si trovino, è una nazione forte, con un futuro davanti a sé, e questa missione culturale estremamente sensibile è stata data a Milli Gorus, il movimento da cui tutto è partito nel lontanissimo 1969.
Oggi Milli Gorus è presente in ogni Paese europeo in cui si trovino comunità di espatriati turchi ed è particolarmente attivo in Germania, dove si trova la sua sede centrale, Austria, Francia e Paesi Bassi. I membri dell’organizzazione sono impegnati in attività sociali, culturali e religiose, aventi come obiettivo ultimo la de-secolarizzazione dei connazionali che, in altri termini, significa riscoperta dell’islam e recupero di usi, costumi e tradizioni.
Nelle file dell’organizzazione militano 165mila persone, la maggior parte delle quali in Germania, una cifra che consente il mantenimento in funzione, per mezzo di lavoro volontario e donazioni, di migliaia di centri culturali, luoghi per la ricreazione, scuole coraniche e moschee. La rete transcontinentale costruita da Milli Gorus, che Foreign Policy ha definito “il lungo braccio di Erdogan in Europa“, riveste un’importanza fondamentale per l’Akp, essendosi rivelata un bacino strategico di voti e un luogo in cui infiltrare spie e cellule dormienti pronte ad essere attivate in ogni momento per seminare caos e compiere omicidi.

