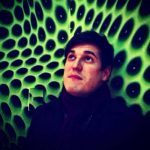La sconfitta dell’esercito ucraino ad Avdiivka, oltre alla morte del blogger e dissidente russo, Alexey Navalny, uniti ai precedenti recenti attacchi del papabile candidato repubblicano alle elezioni presidenziali Donald Trump alla Nato e agli alleati europei colpevoli, a detta dell’ex presidente repubblicano, di non rispettare l’impegno di destinare il 2% del Pil per la Difesa, hanno riacceso il dibattito negli Stati Uniti circa il ruolo della superpotenza americana nello scacchiere internazionale. Anche in relazione al dibattito al Congresso sull’approvazione, ancora in fase di stallo per via dell’opposizione di una parte di repubblicani, del pacchetto di aiuti che contiene al suo interno 95 miliardi di dollari per Ucraina, Israele e Taiwan. Che cosa accadrà all’occidente a guida statunitense se Washington dovesse decidere di ripiegarsi su se stessa e concentrarsi sui problemi interni, anziché assumere il ruolo di “poliziotto globale”? Cosa accadrà se il magnate repubblicano tornerà nello Studio Ovale? Sono domande che stanno animando il dibattito pubblico americano.
Il “Return to normalcy” di Harding come l’America First di Trump
Tutt’altro che una novità, tale quesito rappresenta un vecchio dilemma con cui gli Stati Uniti si confrontano sin da quando il Paese è nato. Come nota infatti Manlio Graziano nel suo saggio L’isola al centro del mondo. Una geopolitica degli Stati Uniti edito da Il Mulino, gli americani hanno avuto l’impressione di “vivere isolati dal resto del mondo grazie alla protezione fisica garantita dagli oceani e grazie all’immensità del territorio che forniva loro tutte le necessarie”. Pertanto, spiega lo studioso, “nell’astrazione temporale dell’ideologia americana, quella condizione particolare è stata assolutizzava e metabolizzata come una ricetta valida per tutte le stagioni”. Un po’ come Trump, nel 1920 il repubblicano dell’Ohio, Warren G. Harding, 29º presidente degli Stati Uniti, stravinse le elezioni proponendo come slogan della sua campagna elettorale “Return to normalcy”, ossia un “ritorno alla normalità” dopo che la Prima Guerra Mondiale e l’influenza spagnola avevamo sconvolto il mondo e gli stessi Usa.
Un “eccezionalismo” inteso come ritorno alla condizione precedente l’intervento nella guerra europea al riparo dal “marcio, corrotto e infido sistema delle transazioni internazionali” che si tradusse in un isolazionismo che fu interrotto da Franklin Roosevelt e dall’avvento della Seconda Guerra Mondiale. Tale concezione dell’America rovesciava completamente la visione del predecessore di Harding, il democratico Woodrow Wilson, promotore della Società delle Nazioni – a cui poi, paradossalmente, gli Stati Uniti non parteciparono, facendola così fallire – che come come notava Henry Kissinger nell’Arte della Diplomazia nel 1915 propose una “dottrina senza precedenti, in cui si affermava che la sicurezza dell’America era inseparabile da quella di tutta l’umanità, sottintendendo con questo che da quel momento gli Stati Uniti si sarebbero opposti all’aggressione ovunque si fosse manifestata”.
Il ritorno del “populismo” di Jackson
Durante il suo primo mandato presidenziale, Donald Trump si fece fotografare nello Studio Ovale con un ritratto alle sue spalle: era quello del settimo presidente Usa Andrew Jackson (dal 1829 al 1837), una fisionomia che ogni americano conosce molto bene perché campeggia sulla banconota da venti dollari, le cui statue che lo immortalano sono finite nel mirino degli attivisti “woke” con l’accusa di essere stato un razzista e uno schiavista. La connessione tra Trump e Jackson fu prima voluta dall’ex stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, e poi resa autorevole dallo storico Walter Russell Mead in un saggio pubblicato nel 2017 sulla rivista Foreign Affairs. Delineando quattro scuole di pensiero della politica estera americana – hamiltoniana, wilsoniana, jeffersoniana e jacksoniana – secondo Mead, i jacksoniani alla Trump sono populisti in campo economico, diffidenti nei confronti delle élite cosmopolite e degli immigrati, e in politica estera tendono a evitare conflitti che coinvolgano gli Stati Uniti all’estero.
Ma se la guerra diventa inevitabile, i jacksoniani, osservava Mead, “cercano la vittoria totale e la resa incondizionata”. Benché la visione di Mead sia stata nel frattempo dibattuta – e anche contestata – il senatore trumpiano JD Vance, contrario all’approvazione del pacchetto di aiuti all’Ucraina, ha sottolineato in una recente intervista rilasciata a News Stateman che l’approccio “jacksoniano” di Trump, è “un misto di estremo scetticismo verso l’intervento all’estero, combinato con una postura estremamente aggressiva quando si interviene”. Se poi questo sarà realmente l’approccio di The Donald qualora vinca le prossime elezioni e non una mera strategia elettorale, è tutto da vedere: anche perché nella sua prima (e contraddittoria) esperienza alla Casa Bianca, Trump si circondò di “falchi” tutt’altro che “isolazionisti” come Mike Pompeo o John Bolton. Uno dei tanti quesiti aperti su una possibile amministrazione Trump 2.0, mentre l’America dibatte sulla propria identità e visione del mondo.