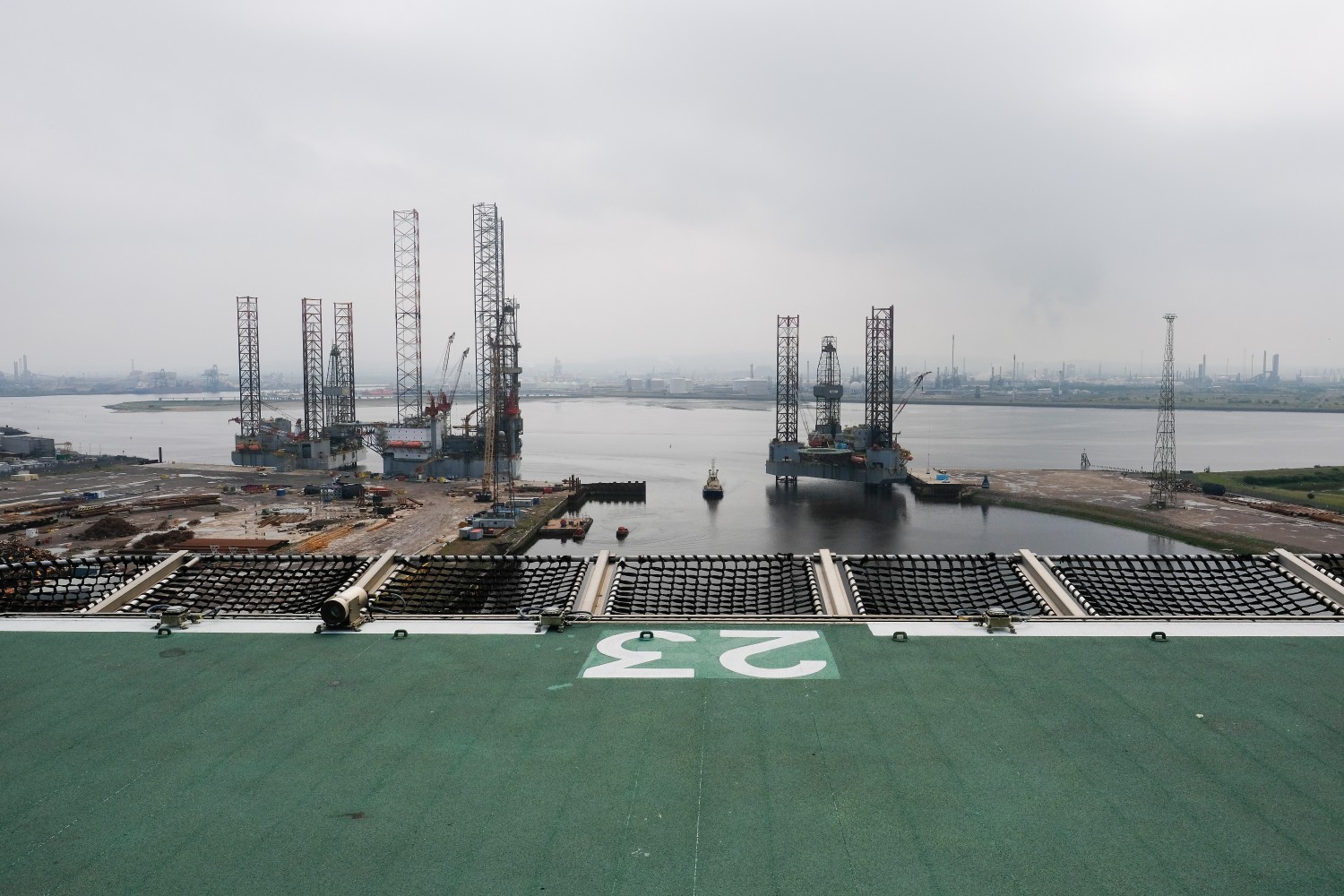Uno degli snodi fondamentali della politica europea, sia comunitaria sia delle singole nazioni del continente, è l’approvvigionamento di gas. Un tema fondamentale, molto spesso trascurato dalla stampa europea, e che però è decisivo riguardo al presente, ma soprattutto al futuro dell’Europa, dell’Unione europea e dei rapporti dei singoli Paesi con i partner extracomunitari che forniscono di idrocarburi il continente. Perché l’Europa, fra i tanti problemi da cui è attanagliata, ne ha uno spesso dimenticato: l’assoluta assenza di risorse energetiche per soddisfare il fabbisogno del continente. La produzione interna di metano si sta riducendo sempre di più, e potrebbe, nei prossimi decenni, fermarsi del tutto. I giacimenti olandesi, norvegesi e del Regno Unito sono in esaurimento e potrebbero arrivare a garantire soltanto un terzo del fabbisogno continentale nel prossimo decennio. Inoltre, seppur non esauriti, sono ad ogni modo destinati, dopo la Brexit, ad essere quasi tutti al di fuori della cornice dell’Unione europea, tranne quelli che fanno capo al governo olandese.
A questo punto, con un’Europa sempre più dipendente dal gas extracomunitario, la corsa a chi debba rifornire il Vecchio Continente della fondamentale risorsa energetica non è un fattore secondario e le scelte geopolitiche dei singoli Stati non possono non passare attraverso una sostanziale quanto indispensabile Realpolitik nei confronti della Russia, degli Stati Uniti e dei Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale. Una Realpolitik che però va contro i dettami all’unità dell’Europa che Bruxelles cerca di imporre nei confronti delle scelte energetiche e di politica estera a tutti i Paesi Membri. Il futuro del Continente si basa in sostanza su un punto interrogativo: da chi dipendere?
A questa domanda l’Europa risponde in modo diverso, a dimostrazione di come sia già difficile oggi, nel 2017, riuscire a pensare una politica comune anche sotto il profilo energetico. L’Europa è già spaccata in due, sia tra Oriente e Occidente sia, in particolare, Sud e Nord. E, anche grazie alla geografia, la Germania si trova in una posizione centrale che consegna a Berlino una fondamentale capacità di guidare le scelte di politica energetica degli altri Paesi. Sono, infatti, i rapporti fra Angela Merkel e Vladimir Putin, e in generale tra Germania e Russia, a modificare i rapporti di forza tra dipendenze dal metano. Ed è proprio questa collaborazione fra Berlino e Mosca in tema di idrocarburi ad essere oggetto dell’ostilità degli Stati Uniti, consapevoli che un’Europa dipendente dal gas russo equivale ad avere un continente formalmente alleato di Washington ma sostanzialmente legato a Mosca anche per pura e semplice sopravvivenza energetica.
Non è un caso che il Senato americano si sia mosso per colpire le persone e le istituzioni legate in qualche modo al progetto North Stream 2 e a Gazprom. Se North Stream raddoppia o se aumenta, in qualunque modo, il rapporto commerciale tra Russia e Germania e quindi fra Russia e Stati Uniti, si creerebbe un blocco economico euroasiatico particolarmente deleterio per le esportazioni statunitensi nel continente europeo. Esportazioni che invece sono essenziali anche nella geopolitica trumpiana, ammesso che ve ne sia una chiara, dal momento che il presidente americano vuole aumentare le esportazioni di gas liquefatto in Europa per entrare nel mercato prima che ne sia tagliato completamente fuori. Chiaramente, il mercato europeo per gli Usa ha un costo enorme rispetto alla Russia, che geograficamente è avvantaggiata in modo netto. Ma la politica può superare a volte l’economia e fare in modo che un attore sia inserito nel mercato più per vantaggi politici che per vantaggi economici. L’arrivo del gas liquefatto nel mercato, pericolo paventato da anni ma che finora non ha avuto grandi effetti, rischia di poter scombinare le carte, specialmente se gli Stati Uniti decidono di diventare esportatori forti in Europa.
Sul fronte meridionale, l’Europa mediterranea avverte la necessità di essere collegata al Nordafrica e al Mediterraneo Orientale. E in questo senso, Paesi come Israele, Iran, Azerbaijan ed Egitto sono attori molto interessati ad aumentare l’esportazione di metano nel continente europeo. L’aumento del fabbisogno, unito a una riduzione della produzione interna, è ovviamente visto come una manna per tutti i quegli Stati che possiedono gas e vedono con interesse un mercato florido come quello europeo. La costruzione del Tap, che avrebbe il suo terminale proprio in Italia, ha lo scopo di diversificare la fornitura energetica in Europa e dall’altro lato di far entrare nuovi competitori nel mercato gasiero evitando che vi sia una sostanziale monopolizzazione del gas da parte di Mosca. A questo vantaggio, di natura prettamente competitiva, si aggiunge però lo svantaggio dei costi: il Tap arriverebbe a costare 45 miliardi di euro, mentre il North Stream 2 circa 16 miliardi. Inoltre, si arriverebbe a una spaccatura delle forniture energetiche europee con la conseguenza di avere un’Europa divisa fra un Nord dipendente dalla Russia e un Sud dipendente potenzialmente dal Medio Oriente e dal Caucaso. È chiaro che questo comporta un cambiamento sia delle politiche comunitarie energetiche sia delle relazioni bilaterali degli Stati con i Paesi extracomunitari. Con conseguenze che non hanno solo a che fare con l’Europa, ma anche con la stabilità del Medio Oriente e del fronte orientale della Nato.