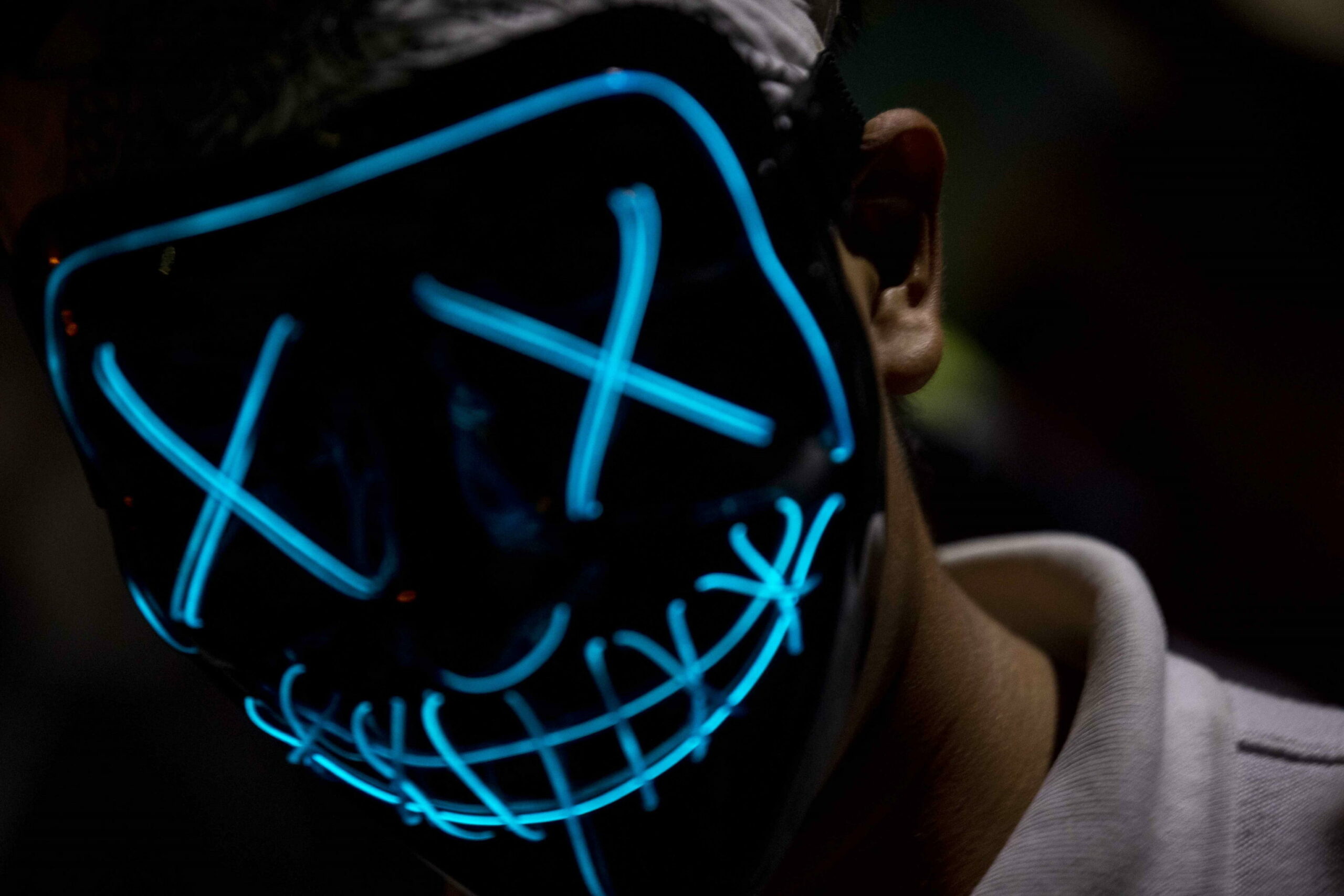Il Nicaragua è quello che in ambito geofilosofico viene definito un “luogo del destino”, ovverosia un posto la cui imperitura centralità nelle relazioni internazionali è stata decretata dalla Provvidenza. È stato calvinisticamente predestinato ad avere un ruolo nella storia del mondo e non esiste Impero o Potenza che abbia la facoltà di alterarne la natura, di revocarne quella grandezza insita nel suo fato.
Benedetto o maledetto della geografia, a seconda di come si interpreti la sua storia, il Nicaragua è stato, è e sempre sarà tante cose simultaneamente: uno di quei (pochi) luoghi del destino in cui si scrive la storia dell’umanità, terra di mezzo perfettamente incuneata tra la cintura dell’instabilità mesoamericana e l’arco della pace costaricano-panamense, ombelico dell’America centrale e vena scoperta della Fortezza America.
Innatamente geostrategico, nonché votato all’antiamericanismo sin dai tempi di José Santos Zelaya López, il Nicaragua è l’incurabile tallone d’Achille degli Stati Uniti, l’eterna vena scoperta della Fortezza America, ed è per questo motivo che, insieme a Cuba e Venezuela, è il Paese sul quale la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese hanno scommesso maggiormente negli ultimi anni. È per questo motivo che è (e sarà) uno dei teatri-chiave della terza guerra mondiale a pezzi.
Eterna vena scoperta delle Americhe
Ciò che rende il Nicaragua un luogo del destino, differenziandolo dal vicinato mesoamericano, è il possesso di una predisposizione genetica di tipo geostrutturale: è nato per essere il vero crocevia tra le Americhe e l’Eurafrasia. La geografia permetterebbe che qui fosse costruito un canale migliore di quello di Panama, sotto ogni punto di vista – dalla capacità alla navigabilità –, ma la storia, o meglio gli Stati Uniti, non lo ha mai concesso.
In principio fu Napoleone III, imperatore di Francia e pioniere dell’antiamericanismo europeo, a fantasticare di costruire un canale di navigazione artificiale che tagliasse in due il Nicaragua, unendo i mercati delle Americhe e dell’Eurafrasia, riscrivendo la geografia del capitalismo globale e rendendo la Figlia prediletta della Chiesa il cuore del mondo.
Napoleone III, che dallo zio aveva ereditato la visionarietà, aveva pensato (quasi) a tutto, dalla satellizzazione del Messico agli accordi sui diritti di sfruttamento del canale col Nicaragua, ma avrebbe pagato a caro prezzo la sottovalutazione del fattore Stati Uniti. Testimone inerme della fucilazione di Massimiliano d’Asburgo, il burattino delle Tuileries giustiziato nel 1867, Napoleone III ripose velocemente il sogno dell’impero latinoamericano nel cassetto, mentre le altre potenze del Vecchio Continente, recepito il messaggio, cominciarono a rispettare con timore reverenziale la dottrina Monroe.
Non un europeo, ma un appartenente alla raza cosmica, ovverosia il presidente José Santos Zelaya López, avrebbe successivamente riaperto la questione del canale. Canale che, a quel punto, gli Stati Uniti avrebbero cominciato a credere fosse maledetto. Una convinzione data dal fatto che, seppellito Napoleone III, il bolivarista Zelaya aveva assunto l’oltraggiosa decisione di chiedere a Germania e Giappone di finanziare il canale dietro la promessa di renderlo uno strumento di ripartizione del potere a livello mondiale.
Nel 1909, fallito ogni tentativo di rovesciare Zelaya a mezzo dell’opposizione liberale, delle forze armate e di altre quinte colonne, gli Stati Uniti decisero di suturare d’urgenza la vena scoperta e sanguinante del continente, deponendone il presidente ribelle e avallandone la caduta in un ciclo di anarchia produttiva utile a inibire a tempo indefinito il riapparire di un esiziale antiamericanismo.
Il Nicaragua e la Triade multipolare
Historia homines docet che, a volte, destabilizzare è meglio che controllare. Perché anche la destabilizzazione è un metodo di gestione delle crisi. Un metodo economico, oltre che machiavellico, che permette all’egemone di turno di mantenere in uno stato di cronica conflittualità un terreno che, se quieto, desterebbe paradossalmente maggiori preoccupazioni.
Scrivere e parlare della destabilizzazione pilotata come metodo di controllo è più che importante, è indispensabile, perché è attraverso l’alimentazione di caos controllato che gli Stati Uniti hanno tenuto a bada l’indomito Nicaragua sin dal dopo-Zelaya. Ma è una strategia che, alla lunga, si è rivelata deleteria, avendo dapprima prodotto Augusto César Sandino e dipoi dato i natali a Daniel Ortega. E con Ortega, più tardi, sono arrivati i sovietici – che, oggi, sono stati sostituiti da russi, cinesi (e iraniani).
I rivali dell’America hanno cominciato a scommettere (seriamente) sulle potenzialità disturbative del piccolo ma pivotale Nicaragua a partire dagli anni Dieci del Duemila, in concomitanza con il ritorno di Ortega al potere, e lo hanno fatto per ragioni simili eppure differenti. Simili perché la Triade del multipolarismo ha intravisto e intravede nel Nicaragua orteguista quel classico amicus meus, inimicus inimici mei di cui si abbisogna sempre. Differenti, ma complementari, perché i cinesi sognano in grande – la costruzione dell’agognato canale di Nicaragua –, i russi con moderatezza – la preservazione del triangolo Caracas-L’Avana-Managua – e gli iraniani in piccolo – il possesso di basi per Hezbollah.
Il Nicaragua oggi (e domani)
Nel 2014, dopo anni di inazione dinanzi al dinamismo della Triade del multipolarismo nella vena scoperta dell’America (e delle Americhe), l’amministrazione Obama decideva di applicare la sempreverde dottrina Monroe al Nicaragua, decretando inconsapevolmente l’avvio di un capitolo-chiave della competizione tra grandi potenze, quello delle periferie al centro.
La rigida applicazione della dottrina Monroe ha permesso agli Stati Uniti di contenere l’incontenibile Nicaragua per sei anni, cioè dal 2014 al 2020, indebolendo gravemente il regime orteguista – sopravvissuto a morte certa grazie alla respirazione artificiale fornita dal Cremlino – e ibernando temporaneamente il (più importante) ramo latinoamericano della Nuova Via della Seta – causa il blocco dei cantieri dell’anti-Panama –, ma nel lungo termine nulla ha potuto per impedire l’inevitabile, ovvero che Russia e Cina iniziassero a scaricare nelle Americhe Latine le tensioni accumulate in Eurasia.
- Chi è Daniel Ortega, il presidente eterno del Nicaragua
- Guerra fredda 2.0: è giunto il momento delle periferie
La georilevanza del Nicaragua, in sintesi, è andata (ri)crescendo di pari passo con l’aumentare della conflittualità negli spazi vitali di Russia e Cina, che ha comportato il definitivo ritorno in scena dell’anti-Panama tra fine 2020 e inizio 2022, ossia ai primordi di quella “pioggia di storia” innescata dall’antesi dello stadio della centralizzazione delle periferie. Ritorno in scena che è stato possibilitato dalla respirazione artificiale garantita dal Cremlino, grazie alla quale Ortega ha potuto stanare quinte colonne e ridurre il livello dello scontro domestico, e che in dodici mesi, dal novembre 2020 al novembre 2021, ha portato il Nicaragua prima ad aprire un consolato onorario in Crimea e dopo a sposare la politica dell’una sola Cina.
È soltanto a partire dalla ricostruzione del contesto generale che si può cogliere l’insospettabile centralità del Nicaragua all’interno della competizione tra grandi potenze, che a fine gennaio è stata riaffermata dalla decisione di Cremlino di elevare la cooperazione militare con la presidenza Ortega – una risposta alle operazioni di disturbo occidentali nel lebensraum eurasiatico della Russia, in particolare in Ucraina e Kazakistan – e che, molto probabilmente, nel prossimo futuro verrà rafforzata da altri eventi.
Scrivere del Nicaragua è fondamentale, in definitiva, perché non è una periferia come le altre: è la periferia. La periferia che può tutto. Che può diventare centro se mai riuscirà ad avere un proprio canale – e l’adesione alla politica dell’una sola Cina non è che il corteggiamento di un abile adulatore. Che può catalizzare od affossare la transizione multipolare – perciò non vanno escluse delle “operazioni di recupero” da parte degli Stati Uniti. E che, disturbando l’arco della pace (leggasi carovane e Panama) e vitalizzando quella che per la Casa Bianca è la Troika della tirannia – il triangolo Caracas-L’Avana-Managua –, può coartare il centro a ripiegare su se stesso.