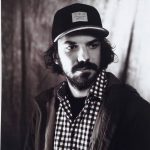Il vincitore del Nobel per la Pace 2019 ha finalmente un nome: si tratta di Abiy Ahmed Ali, il primo ministro dell’Etiopia. Una scelta in qualche maniera inattesa, viste le sempre più insistenti voci che negli ultimi mesi davano quasi per scontato il conferimento del premio all’attivista svedese per il clima Greta Thunberg, ma che non deve cogliere del tutto impreparati: Ahmed compariva infatti tra gli altri nomi papabili per il riconoscimento, assieme tra gli altri ai primi ministri greco e nordmacedone Tsipras e Zaev, artefici dello storico Accordo di Prespa, e all’attivista brasiliano Raoni Metuktire. Ma chi è Abiy Ahmed? Quali sono le ragioni che hanno portato a preferirlo ad altri candidati, ugualmente quotati?
Una carriera fulminea
Nato nel 1976, Ahmed è originario della regione di Oromia, situata nel centro-sud dell’Etiopia. Figlio di un musulmano Oromo e di una cristiana ortodossa Amhara (mentre lui stesso è membro della Chiesa evangelica locale), ovvero le due etnie dominanti nel Paese, il suo nome è un’abbreviazione di Abiyot, ovvero “Rivoluzione”, in onore della sollevazione militare di stampo socialista che nel 1974 condusse al rovesciamento dell’imperatore Hailé Selassié. Ironicamente, a partire dai primi anni Novanta il giovane Ahmed viene annoverato tra i più strenui oppositori di quel regime, riuscendo in seguito a scalare rapidamente i ranghi dell’esercito fino al grado di luogotenente colonnello e svolgendo attività di intelligence sia come parte del contingente Onu in Ruanda che, successivamente, nel corso della guerra tra Etiopia ed Eritrea intercorsa tra il 1998 e il 2000. La sua carriera militare si interrompe ufficialmente soltanto nel 2010, quando prende la decisione di entrare in politica a tempo pieno come esponente dell’Odp, l’Organizzazione Democratica del Popolo Oromo: la sua ascesa al Parlamento non gli impedisce tuttavia di completare un dottorato in Studi sulla Pace e la Sicurezza, conferitogli nel 2017 dall’Università di Addis Abeba.
Il salvatore del suo Paese?
Già prima della consacrazione a livello nazionale, Ahmed si era fatto notare per le sue politiche di stampo progressista e riconciliatorio, in particolare riguardo il tema dell’espropriazione delle terre nella sua regione natale, spesso fonte di violenze e conflitti interetnici: molti osservatori ritengono che sia stata proprio quella la spinta propulsiva a condurlo alla vittoria delle elezioni dell’aprile 2018, poco dopo aver ottenuto la leadership del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, la coalizione che raggruppa i principali partiti di centro-sinistra etiopi (tra i quali l’Odp). Fin dal suo discorso inaugurale, il nuovo premier si fa notare soprattutto per due punti programmatici: la volontà di chiudere definitivamente con il passato, promettendo liberalizzazioni, leggi anticorruzione ed amnistie di prigionieri politica, e il desiderio di riavvicinarsi all’Eritrea, “eterno nemico” nella regione. Buoni propositi indubbiamente forti, ma che vengono presto implementati con la decisione di liberare migliaia di detenuti e di abrogare la legge antiterrorismo in vigore fino a quel punto, definita dallo stesso Ahmed draconiana. Un gesto distensivo che però non ha mancato di generare critiche, in primis quella di aver perdonato indiscriminatamente personaggi potenzialmente pericolosi per poi “gettare le chiavi”. E in effetti, il fallito golpe che lo scorso giugno ha insanguinato la regione del Tigray (dove si trovano non pochi oppositori di Ahmed) ha avuto origine proprio da un gruppo di amnistiati, tra cui il capo dei servizi di sicurezza locali Asamnew Tsige (ucciso durante gli scontri).
A livello internazionale, Ahmed si è invece fatto notare per i suoi sforzi per porre fine alle dispute con l’Eritrea del dittatore Isaias Afwerki, culminati nel settembre del 2018 in uno storico accordo di pace che possiamo definire la pietra angolare delle ragioni che hanno condotto al conferimento del Nobel al primo ministro etiope. Un avvenimento importantissimo, anticipato dalla riapertura dei flussi tra i due Paesi e dal regolamento di alcune annose dispute di confine, visto da molti come un segnale di cambiamento per tutta l’Africa, ma che va in ogni caso legato a quella che si sta rapidamente trasformando in una vera e propria partita a scacchi tra le potenze del Golfo per il controllo del Corno d’Africa: non a caso, il trattato è stato firmato a Riad con il beneplacito di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che dal canto loro ne hanno approfittato per inserire tra le clausole proficui accordi per l’invio di manodopera, appalti dal valore milionario e patti per lo sviluppo infrastrutturale. Una sorta di “pacchetto extra” che in teoria dovrebbe favorire anche lo sviluppo dell’Etiopia, ma che nonostante tutto fa pensare anche a una volontà di sottrarre la sponda occidentale del Mar Rosso alla sempre lunga ombra della Cina.
L’enigma di Addis Abeba
Con questa premesse in mente, potremmo definire Abiy Ahmed un vero e proprio enigma. La sua volontà di rendere l’Etiopia uno Stato moderno, sicuro e appetibile per gli investitori esteri deve infatti necessariamente scontrarsi con una realtà che, fuori da Addis Abeba, continua ad essere dominata dalla miseria e dagli scontri sociali, interetnici (nel 2018 1.5 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case) e religiosi, come quello ancora in corso nel sud del Paese tra l’etnia Sidama – che dopo numerosi tentennamenti del governo a novembre voterà per la propria costituzione in regione autonoma – e la polizia locale. Oltre a questo, alcune promesse sembrano non essere state mantenute: nonostante avesse promesso un ritorno alla libertà di stampa, dalla sua elezione ad oggi Ahmed ha infatti dato una sola conferenza stampa priva di domande concordate in precedenza (e di risposte conseguentemente già scritte e preparate), mentre sembra ormai conclamata una sorta di “stretta” sui militari di etnia Tigrina (che dal canto loro hanno definito le politiche del premier “una scusa per fare pulizia etnica”), che sarebbero stati estromessi in blocco dall’esercito nei mesi passati proprio per evitare il ripetersi del tentato golpe dello scorso giugno.
Risulta dunque chiaro come il nuovo Premio Nobel per la Pace sia un personaggio nel quale si concentrano differenti ambizioni: quella di aiutare il proprio Paese ad uscire da un impasse che dura da almeno quarant’anni e quella di consolidare il proprio potere “tenendo sotto controllo” quelle etnie o segmenti di opinione pubblica che si oppongono al suo programma. Un dualismo complesso che però, con la decisione dell’Accademia di conferirgli questo enorme riconoscimento, rischia di sbilanciarsi completamente verso il solo primo aspetto.