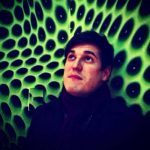Come scrive Graham Allison nel suo Destinati alla Guerra (Fazi Editore, 2018), nel 2011, l’allora segretario di Stato Hillary Clinton annunciò, con notevole clamore, un’importante “svolta” nella politica estera americana, che avrebbe reindirizzato l’attenzione e le risorse di Washington dal Medio Oriente verso l’Asia, al fine di fronteggiare l’ascesa della Cina nella regione. Citando le parole del presidente Barack Obama: “Dopo un decennio in cui abbiamo combattuto due guerre a caro prezzo, in termini di sangue e di risorse del tesoro, gli Stati Uniti stanno rivolgendo la loro attenzione al vasto potenziale della regione pacifico-asiatico”. Obama promise di aumentare la presenza diplomatica, economica e militare dell’America nella regione.
Meglio conosciuto come Pivot to Asia, il “grande riequilibrio” annunciato da Obama e Clinton, come nota Allison, rimase sulla carta e una grande aspirazione. Come ha ricordato un funzionario della Casa Bianca sotto Obama: “Non c’è mai stata la sensazione che avessimo davvero voltato strada rispetto al Medio Oriente. Circa l’80% delle nostre riunioni più importanti presso il Consiglio per la sicurezza nazionale si è concentrato sul Medio Oriente”. Oltre alle guerre in Iraq e Afghanistan, le cosiddette “Primavere arabe” del 2011 e soprattutto il conflitto in Siria e la lotta contro lo Stato islamico, accantonarono definitivamente ogni tentativo di svolta dell’amministrazione Obama.
L’amministrazione Trump ha avviato una guerra commerciale con Pechino mentre ha mostrato una certa insofferenza per l’Ue a guida tedesca e, in particolare, per il surplus commerciale di Berlino: il presidente Donald Trump, inoltre, preferisce di gran lunga trattare con i singoli Stati che con l’intricata casta di burocrati dell’Ue. Da pragmatico, ha perfettamente compreso che a tirare le redini dell’Unione europea sono Germania e Francia. Nel complesso, le relazioni fra Ue e Washington sono peggiorate e i leader europei come Angela Merkel e Emmanuel Macron sperano in cuor loro che il prossimo presidente degli Stati Uniti sia il democratico Joe Biden, ex vicepresidente di Obama. All’inizio del 2019, alla vigilia della Conferenza di sicurezza di Monaco, Biden ha inviato un messaggio rassicurante ai politici, diplomatici e leader militari europei preoccupati per il disimpegno americano: “Torneremo”.
L’Europa “è un vegetariano in un mondo di carnivori”
Come scrivono Alina Polyakova e Benjamin Haddad su Foreign Affairs, in un articolo intitolato Europe Alone (l’Europa sola), nonostante le rassicurazioni di Joe Biden e le speranze dei leader europeisti, “una nuova amministrazione degli Stati Uniti potrebbe alleviare alcune delle attuali tensioni transatlantiche”, ad esempio “eliminando le tariffe sull’acciaio e sull’alluminio europeo o rientrando nell’accordo sul clima di Parigi”. Ma queste correzioni, osservano gli esperti sull’autorevole rivista americana, “non risolveranno il problema alla radice. La spaccatura tra Stati Uniti ed Europa non è iniziata con Trump, né si concluderà con lui”. Piuttosto che cedere alla nostalgia, affermano, “i leader statunitensi ed europei dovrebbero valutare con onestà il percorso che li ha portati all’attuale crisi: il primo passo verso la creazione di una partnership transatlantica più matura e lungimirante”.
La crisi odierna, osservano, “è prima di tutto un risultato della forte asimmetria tra gli Stati Uniti e l’Europa. Per molto tempo, entrambe le parti hanno accettato questo squilibrio, lo hanno persino coltivato. L’Europa è rimasta sottomessa in cambio di un posto sotto l’ombrello della difesa degli Stati Uniti”. Ma la fine della Guerra fredda, l’11 settembre, e soprattutto l’ascesa della Cina, “hanno spostato altrove le priorità di sicurezza di Washington, lasciando l’Europa sola. Oggi il continente è ‘un vegetariano in un mondo di carnivori’, come disse Sigmar Gabriel, allora ministro degli esteri della Germania”. Infatti, le visioni europee di “autonomia strategica” dagli Stati Uniti, spesso invocate dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e dal presidente francese Macron, sono rimaste solo sulla carta.
Inoltre, la confederazione dell’Unione europea è composta da Stati membri che non rinunciano al nazionalismo e a perseguire i propri interessi nazionali, spesso in contrasto fra loro. Gli Stati dell’Europa dell’est, per esempio, sono più fedeli a Washington che a Bruxelles. Il dominio economico della Germania, che irritava Washington già dai tempi di Barack Obama, quando il Tesoro statunitense accusava Berlino di puntare troppo sull’export e non sulla domanda interna, indebolisce Stati come l’Italia, sempre più scettica nei confronti dell’integrazione europea.
La spaccatura fra Usa ed Ue non è iniziata con Trump
Come nota Foreign Affairs, la crisi dei rapporti transatlantici non è iniziata con Trump. Obama annunciò il già citato “Pivot to Asia”, cancellando i piani per costruire un sistema di difesa antimissilistica degli Stati Uniti in Polonia con stazioni radar nella Repubblica Ceca e, successivamente, ritirando due brigate dell’esercito statunitense dall’Europa. Le cose cambiarono con il golpe di Euromaidan in Ucraina e la successiva annessione della Crimea da parte della Russia.
Tutti incolpano Trump dell’attuale crisi delle relazioni transatlantiche ma, in realtà, anche con un’eventuale vittoria di un democratico moderato come Joe Biden, le tensioni rimarranno. Gli Usa continueranno a criticare il comportamento della Germania e le sue ambizioni imperiali (economiche) sul resto del continente ma, soprattutto, si concentreranno sempre di più sulla sfida alla Cina e al contenimento di Pechino in Asia. Che The Donald sia il prossimo inquilino della Casa Bianca o meno.
Washington si concentrerà sulla sfida a Pechino
Nel gennaio del 2018 il Pentagono ha svelato la nuova “strategia di difesa nazionale” che definisce la Cina e la Russia le due maggiori minacce agli interessi diretti degli Stati Uniti. Una svolta epocale che ha segnato un cambiamento profondo nella politica di difesa degli Usa dopo la War on Terror inaugurata dall’amministrazione di George W. Bush post-11 settembre 2001. E tra le due, Pechino è percepita dall’élite politica di Washington come la minaccia numero uno che la superpotenza statunitense deve fronteggiare.
Secondo il politologo Stephen M. Walt, “la politica estera e di difesa degli Stati Uniti si concentrerà principalmente sul contrasto alla Cina. Oltre a cercare di rallentare gli sforzi della Cina per ottenere vantaggi in una serie di tecnologie emergenti, gli Stati Uniti cercheranno anche di impedire a Pechino di stabilire una posizione dominante in Asia”. Tuttavia, afferma, “mantenere la posizione degli Stati Uniti in Asia non sarà facile, perché le distanze sono enormi, gli alleati asiatici dell’America vogliono preservare i loro legami economici con la Cina, e alcuni di questi alleati non si amano molto”.
Al contrario, nel Vecchio Continente nessun Paese – tra cui la Russia – è in grado di minacciare di dominare l’Europa. Per questo motivo, osserva Walt, “il ruolo degli Stati Uniti continuerà a diminuire (come è accaduto dalla fine della Guerra fredda). Nonostante i timori allarmistici su una Russia in ripresa, è troppo debole per porre la stessa minaccia all’Europa della vecchia Unione Sovietica”.