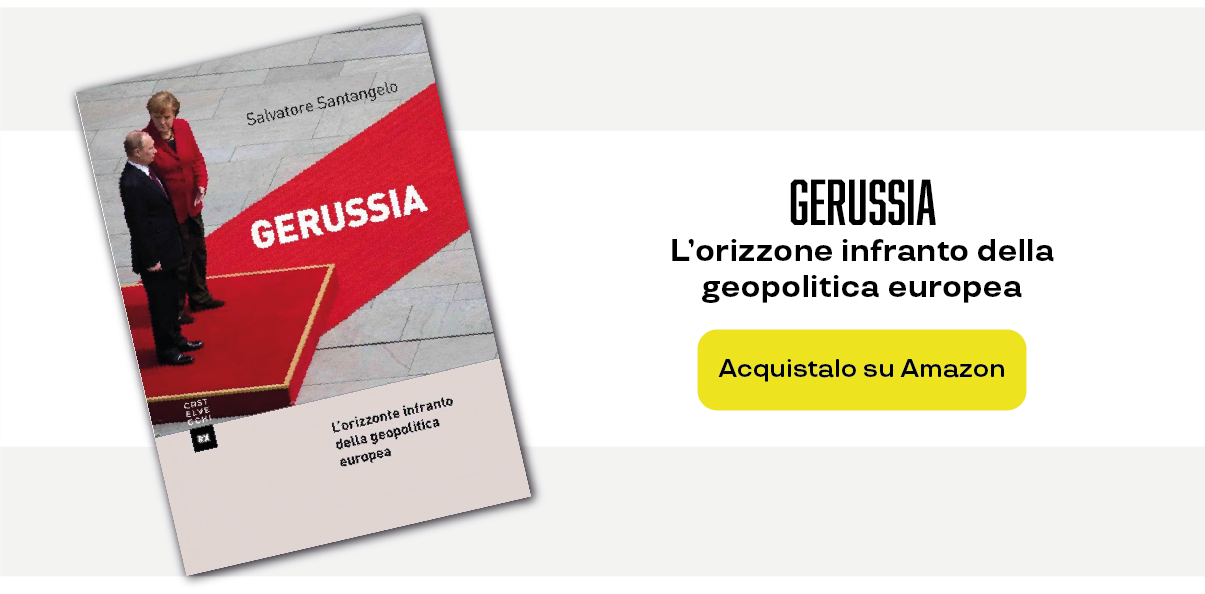Della crisi ucraina si è scritto e si sta scrivendo di tutto. Per alcuni è una resa dei conti tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskij. Per altri è un braccio di ferro tra Russia e Stati Uniti scaturito dalla volontà della prima di raggiungere un’intesa coi secondi nella sfera dell’architettura della sicurezza europea. Ma pochi hanno indagato un terzo movente, perfettamente complementare ai primi due, ovverosia il fattore GeRussia.
Le origini della crisi
La crisi ucraina è il classico nodo venuto al pettine. Un nodo che fa male, quasi inestricabile, che viene voglia di rimuovere con le forbici. Ma non si può eliminare la ciocca annodata senza rovinare l’intero taglio di capelli, perciò alle forbici va preferita la pazienza, che costituisce l’unico (vero) modo di sciogliere il nodo.
La crisi ucraina è un nodo la cui formazione è cominciata all’indomani della dissoluzione dell’Unione sovietica, con il graduale ingresso nel campo euroatlantico di ex repubbliche sovietiche – come i Baltici – e membri del Patto di Varsavia – dalla Polonia alla Bulgaria –, e che è esplosa con forza nel 2022, anziché nel 2017 o nel 2018, per una ragione precisa: il sistema unipolare non è mai stato così traballante, così vicino alla deflagrazione.
- Infowar: una guerra tra Occidente e Russia senza esclusione di colpi
- Ucraina, prove di de-escalation
Diversi sono gli eventi che hanno incoraggiato la Federazione russa a premere l’acceleratore, a tentare questo rischio calcolato che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso per mesi, e tutti sono accomunati da un elemento: sarebbero indicativi del declino dell’Impero americano e spianerebbero la strada, dunque, al superamento del sistema unipolare.
Tre eventi, in particolare, hanno esorcizzato il timore del Cremlino di dare semaforo verde ad un’escalazione verticale controllata dai molteplici scenari: la nuova guerra civile americana, l’assalto a Capitol Hill e la ritirata dall’Afghanistan. La prima ha palesato lo stato di salute precario del tessuto sociale a stelle e strisce, preconizzato profeticamente già da Zbigniew Brzezinski e George Soros negli anni Novanta. Il secondo ha reso chiara l’esposizione dell’America-istituzione, cioè dell’establishment, alla radicalizzazione sociale e agli opposti estremismi. E la terza, invece, è stata interpretata più come un canto del cigno che come un disimpegno strategico.
La crisi ucraina non nasce nel 2014, cioè quando il trio Obama-Biden-Blinken mise a segno la rivoluzione colorata più significativa dell’era postsovietica, ma si è presentata otto anni più tardi, in definitiva, non perché la Russia è più forte – non lo è, la sua forza è data dall’asse con la Cina –, ma perché la Comunità euroatlantica è più debole – l’Unione europea disunita, gli Stati Uniti in contrazione imperiale.
Il parere dell’esperto
Molte sono le interpretazioni sulla crisi ucraina, e (quasi) tutte contengono un elemento di verità: redde rationem tra il Cremlino e il Marinskij, monito all’Alleanza Atlantica, prova di forza coordinata con la Cina, volontà di incrementare il potere negoziale al tavolo delle trattative sulla nuova Jalta con gli Stati Uniti. Poco e nulla si è scritto, però, a proposito della rilevanza del fattore Germania all’interno della crisi. Fattore che, come indicano alcuni fatti, potrebbe essere stato tutt’altro che marginale.
Per capire se, quanto e come conta e ha contato il fattore Germania all’interno della crisi ucraina, abbiamo intervistato uno dei massimi esperti in materia di relazioni russo-tedesche: il politologo Salvatore Santangelo, già autore di GeRussia. L’orizzonte infranto della geopolitica europea (Castelvecchi Editore).
Dottor Santangelo, questa crisi rappresenta una resa dei conti tra il Cremlino e la classe dirigente ucraina post-Euromaidan ed è anche, e soprattutto, un evento da inquadrare all’interno di un contesto ben definito: le trattative di piombo russo-americane sul ridisegnamento dell’architettura della sicurezza europea. Ma è azzardato vedere anche dell’altro, magari un nuovo tentativo da parte di un’amministrazione americana di sabotare le relazioni russo-tedesche? Le dichiarazioni di Joe Biden, che sin dagli albori della crisi ha parlato con insistenza di colpire il Nord Stream 2 in caso di guerra, inducono a pensarlo.
Intanto diciamo che Russi e Tedeschi, in particolare i Tedeschi, dopo aver abbandonato la (moderata) visione del Cancelliere di Ferro – Otto von Bismarck –, sono stati particolarmente bravi a sabotare quella che Keynes – già dalla fine della Prima guerra mondiale – aveva indicato come una delle vie per pacificare e stabilizzare una delle zone più turbolente del nostro Continente.
Occorre notare, tra l’altro, che questa relazione genera automaticamente delle strane tensioni ideologiche: perché quando la Russia guarda alla Germania lo fa per affrancarsi dalla sua dimensione asiatica, per imboccare la via della modernizzazione avvicinandosi all’Europa; mentre la marcia verso est della Germania, al contrario, mette in moto delle pulsioni per certi versi arcaiche, anche se oggi sensibilmente moderate, che affondano le origini nelle radici prussiane della costruzione statuale tedesca – con tutto quello che ciò che comporta. Potremmo definirla una visione eurasista. Si tratta, quindi, di temi da maneggiare con grande prudenza e delicatezza.
Detto questo, il Nord Stream e il suo raddoppio rappresentano un segnale di un’autonomia strategica iniziata con le posizioni pacifiste del 2003 e continuata con l’astensione tedesca – nel quadro Onu – sul voto per l’imposizione della no fly zone sui cieli libici nel 2011. Ed è un’autonomia strategica che gli Stati Uniti non possono che guardare con un certo fastidio. Un fastidio messo in scena, per esempio, nel film Il ponte delle spie di Steven Spielberg, in cui traspare la nostalgia provata da un pezzo della classe dirigente di Washington per la “semplicità” della Guerra fredda.
Gli Stati Uniti hanno pagato un costo alto per esportare la democrazia in Italia, Giappone e Germania, e hanno tollerato – in chiave antisovietica – che i nemici di ieri godessero dei dividendi della lunga pace seguita alla Seconda guerra mondiale, ma dopo aver sacrificato almeno due generazioni del proprio ceto medio – gli sconfitti della globalizzazione cominciata con la diplomazia del ping pong, che ha aperto la strada alla Cina sulle rovine dell’Unione Sovietica – sono meno disposti, oggi, a concedere margini di manovra. Mordono il freno quando alleati che, dal loro punto di vista, dovrebbero essere riconoscenti, non si impegnano a marginalizzare definitivamente Mosca e non riconoscono l’esigenza di porre fine a quella che chiamiamo appunto globalizzazione per evitare che la Cina trasformi completamente il capitale economico fin qui accumulato in capitale geopolitico.
Nel cuore degli Stati Uniti, oggi, ribollono dei laceranti conflitti che hanno offuscato la loro leadership internazionale e rendono loro difficile esercitare il ruolo guida ereditato dalla fase unipolare. Il tutto è condito da una serie di madornali errori strategici, in primis – dopo il fallimento della stagione neocon – l’ambizione del doppio contenimento, che non ha fatto altro che avvicinare ancor di più Cina e Russia, disarticolando alleanze che si ritenevano, fino ad oggi, inscalfibili.
Del ruolo dell’Europa, o meglio delle potenze europee, si è parlato poco in queste settimane febbrili. I più si sono limitati a constatare (giustamente) la disunità regnante tra i membri dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione europea, guardando con scetticismo e valutando al ribasso il concerto tra Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. Concerto che io, invece, ho trovato eccelso: telefonate, vertici, pressioni, offerte di mediazione. Credo che il duo, costringendo l’Ucraina a rinunciare pubblicamente all’adesione alla Nato e intermediando tra i due belligeranti, abbia giocato un ruolo persuasivo non di poco conto. Lei cosa ne pensa: quale è stato l’impatto della diplomazia neogollista di Macron e, soprattutto, della più bistrattata diplomazia triangolare di Scholz?
Sinceramente, su questo preferisco mantenere un giudizio sospeso. La vicenda è ancora aperta e lo sarà per mesi. E il tempo non è certamente favorevole per una potenza declinante come la Russia, che non è altro che un moncone amputato del vecchio Impero zarista e dell’Unione Sovietica.
Per quanto riguarda l’Europa, è ancora una costruzione in itinere, anch’essa è sottoposta a delle violente sollecitazioni e possiede una classe dirigente che, soltanto parzialmente, è all’altezza delle sfide da affrontare.
- Il significato della visita di Scholz a Washington
- Putin: “Non vogliamo la guerra”. Prove di intesa con Scholz
L’Italia che ruolo ha avuto in questa crisi: autonoma o accodata all’asse franco-tedesco?
Questa domanda, in realtà, è un po’ maliziosa, perché dovrebbe portare a rispondere che l’Italia è stata oggettivamente fuori dai radar. Forse è così, ma dovremmo chiederci se è un bene o un male.
Premesso che truppe italiane – inquadrate nel dispositivo Nato – sono già ai confini della Russia (in Lettonia) e dell’Ucraina (in Romania), e quindi in prima linea, negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di eventi che dovrebbero farci oggettivamente preoccupare: politici (ma anche diplomatici in carriera) che con estrema disinvoltura sono passati dal sostenere la Nuova Via della Seta a farsi interpreti di un atlantismo dogmatico, e altri, storicamente impregnati di una cultura antiamericana pronti – in vista di un incarico di governo – a sottoscrivere dichiarazioni che descrivono Putin come la più grave minaccia alla pace in Europa. Quindi, tutto e il contrario di tutto. E questo è accaduto senza che il nuovo «Arco costituzionale» – che dal 1991 in poi ha sostenuto la stagione più interventista della storia repubblicana post-seconda guerra mondiale, con ripetuti fallimenti nei Balcani, in Somalia, Mesopotamia, Afghanistan e Libia – si sia minimamente posto il problema di riflettere sul senso di questi fallimenti, sui loro costi umani, finanziari e politici.
Bettino Craxi lo ha detto certamente meglio di me: “I duri, sovente, sono pericolosi perché minati da un’intima fragilità. È molto meglio in politica, come in generale nella vita, avere a che fare con uomini di carattere capaci di essere giusti e leali”. E quello che vale per gli uomini vale anche per le nazioni.
Quindi è auspicabile un approccio meno attivo?
I più scatenati, oggi, sono quei Paesi o in (perenne) crisi di identità o la cui architettura sociopolitica è minacciata da sfide per certi versi inedite e che hanno la necessità di scaricare altrove le proprie tensioni interne. Oltre a ciò, forse, gli italiani non hanno sufficientemente riflettuto su quanto siano costati a noi, ma anche al mondo intero, tutti i momenti di assertività in cui il Paese si è affacciato sul palcoscenico mondiale.
Senza abbracciare la pur convincente tesi di Sergio Valzania e Franco Cardini sul fatto che la guerra di Libia del 1911 abbia di fatto messo in moto il diabolico meccanismo che ha portato al finale collasso dell’Impero ottomano, con le successive guerre balcaniche del 1912 e del 1913, e quindi avrebbe innescato l’«Inutile strage», certamente – dal tardo ingresso nell’elenco delle potenze coloniali alla Prima guerra mondiale, da annoverare tra quei fattori che hanno prolungato il conflitto, fino alla follia del Fascismo – si può dire che un’Italia assertiva è un’Italia pericolosa per sé e per gli altri.
E, poi, come si fa a prendere una posizione chiara se pezzi importanti del Paese vanno sempre in ordine sparso? Anche se in molti abbiamo accolto la riunione degli amministratori delegati dei principali gruppi economici italiani con Putin come un segnale che chi aveva informazioni di prima mano non credeva alla propaganda bellicista, c’è modo e modo di far arrivare certi messaggi. Immaginiamo le risposte imbarazzate che Mario Draghi ha dovuto dare ai partner occidentali.
L’opinione pubblica italiana non è bellicista, anche se in passato ha dato prova di essere pronta a seguire verso il baratro più di un pifferaio magico, e la nostra economia, anche per decisioni scellerate del passato, è fin troppo esposta al problema degli approvvigionamenti e dell’aumento dei costi energetici, anche se meno di altre – penso alla Germania –, mentre le nostre filiere dell’export hanno bisogno di più Europa, di una globalizzazione temperata e di stabilità internazionale.
Si tratta di un’equazione con soltanto tre variabili, quindi non è particolarmente difficile da risolvere. Certo, la politica, e ancor di più la politica internazionale, non funziona in modo così lineare, ma almeno cerchiamo di sgombrare il campo dalla dannosa retorica che sta soffocando il dibattito sia generalista sia accademico.
Tornando alla Germania, che sembra essere il veridico obiettivo dell’amministrazione Biden, Scholz è più debole o più forte, in termini di autonomia e potere negoziale, rispetto ad Angela Merkel?
Molto di quanto detto in precedenza per l’Italia vale (amplificato) per la Germania, anche se con effetti, dato il peso specifico diverso, ben più devastanti, come ci insegna la storia. I due Paesi, tra l’altro, sono molto più legati di quello che si tende a pensare, e su questo tema andrebbe sviluppata una riflessione anche politica. Ma non è questo il contesto.
La Germania percepisce la propria base di forza – l’industria manifatturiera votata all’esportazione – come particolarmente esposta sia alle crisi internazionali sia alla transizione energetica dettata dall’adesione all’agenda di contrasto al cambiamento climatico. Agenda che, rinunciando di fatto al vantaggio competitivo nei confronti della Cina, la Germania sta perseguendo con netta convinzione. Detto en passant, questa convinta adesione – e i costi che stanno e si dovranno affrontare – dovrebbe far riflettere i tanti negazionisti che si trovano anche in questo campo.
I tedeschi sentono che la stagione della globalizzazione in cui hanno prosperato è a rischio, sono oggettivamente preoccupati delle torsioni autoritarie di due Paesi con cui hanno delle relazioni strategiche, cioè Cina e Russia, ma a differenza degli est-europei e degli anglosassoni ritengono che una postura eccessivamente muscolare possa accentuare, piuttosto che ridurre, questa dinamica e che il libero commercio e la crescita economica possano riuscire dove non hanno avuto successo le sanzioni. Questo crea ulteriori tensioni con gli Alleati. Inoltre, avvertono come minacciata l’integrità delle Istituzioni e del quadro comunitario a cui hanno legato la propria pace e la propria stabilità. E tutto questo sta accadendo molto rapidamente.
Può spiegare meglio?
Come il bambino olandese che attende i soccorsi davanti alla diga che perde acqua, i tedeschi pregano che i buchi siano ravvicinati e comunque siano meno di dieci. La Grande coalizione – architrave che negli anni ha sostenuto con forza la posizione della Merkel – avrebbe dato maggiori garanzie in una fase così turbolenta, ma gli accidenti della politica hanno dato al neo-cancelliere un altro perimetro, certamente e paradossalmente più contraddittorio.
Date queste premesse, Scholz ha imboccato la cruna dell’ago con passo deciso e aggiungerei di nuovo, date le premesse, anche con un certo coraggio. Va detto che la storia della socialdemocrazia tedesca ci aveva dato già buone prove in questo senso. Comunque, tutto è in movimento.
Qual è il destino della GeRussia: riuscirà a vincere le pressioni provenienti dagli Stati Uniti o è destinata a rimanere un «asse troncato» e dal potenziale inespresso?
GeRussia è solo uno dei possibili risultati dell’equazione strategica che si sviluppa lungo l’asse Berlino-Mosca. Proprio per questo, il titolo della mia prossima riflessione su questo tema è più problematico: Tra russi e tedeschi. Storia e attualità di un destino geografico (sempre per Castelvecchi).
A trent’anni dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, che Putin ha definito “la tragedia geopolitica del XX secolo”, proverò a definire – attraverso una lettura multidisciplinare, la traiettoria strategica e la dimensione geografica della peculiare relazione tra Germania e Russia. E ciò, partendo dal presupposto che le attuali contraddizioni interne all’Unione europea non possono essere comprese se non si analizza lo scarto tra il dichiarato orientamento delle Istituzioni comunitarie e la spinta sovranista e identitaria dei Paesi dell’Est. Questi ultimi, appunto, sono gli Stati che si trovano “tra russi e tedeschi” e che, anche a causa del peso delle tragedie del Novecento, dimostrano una natura premoderna, che li colloca in un contesto conflittuale; una logica ben compresa da alcuni attori extraeuropei, che tendono cinicamente a strumentalizzarla.
Siamo di fronte ad uno spazio geografico dove si incontrano e scontrano interessi e disegni e, al tempo stesso, esiste una dimensione valoriale polarizzante. Si tratta di dinamiche in grado di costruire e definire, oppure sconvolgere, quegli equilibri dai quali dipenderà in larga misura il futuro del nostro Continente.
GeRussia potrà funzionare solo se Germania e Russia riusciranno a disinnescare le legittime paure e diffidenze dei popoli che vivono compressi tra questi due ingombranti vicini. Il Nord Stream, invece, la grande infrastruttura energetica in cui questa traiettoria sembra oggi concretizzarsi, appare ispirata, più che a questo idealismo, a un pragmatismo che rischia di essere cinico e di corto respiro.