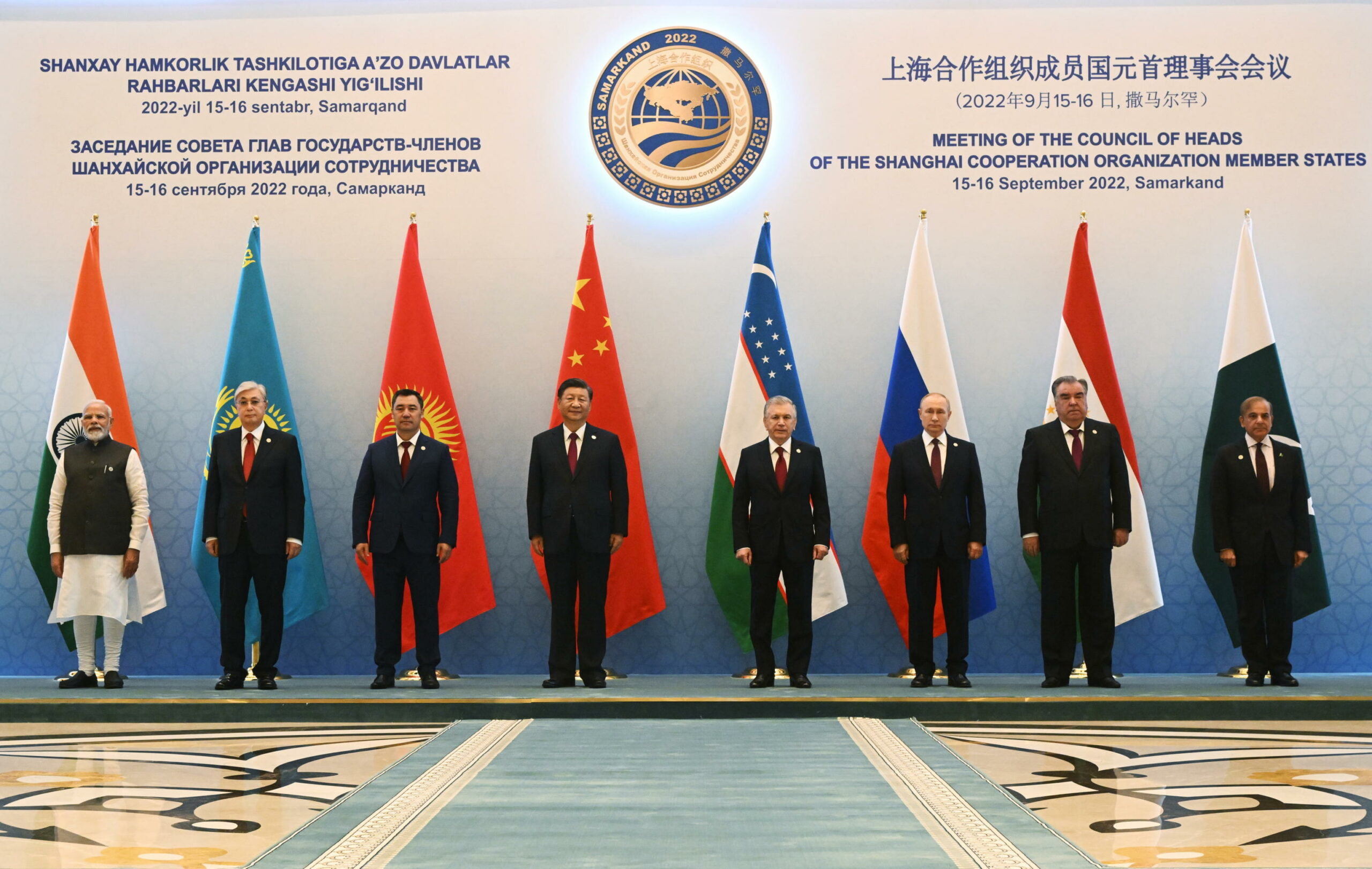Nell’arco di sei mesi il quadro politico internazionale ha subito uno stravolgimento epocale. A partire dal repentino ritiro della Nato, e quindi dell’occidente, dall’Afghanistan e terminando con il conflitto in Ucraina, si è venuta a creare una situazione in cui il bilanciamento di potenza tra gli attori globali è andato riequilibrandosi, segnando il declino di alcuni e l’affermazione ulteriore di altri.
La cartina tornasole di questo nuovo assetto è, ancora una volta, l’Asia centrale. La perdita dell’Afghanistan ha costretto gli Stati Uniti ad arretrare rivolgendosi, nuovamente, a un partner scomodo e ambiguo come il Pakistan, che è anche – per lo stesso motivo – diventato importante per la geopolitica italiana nel quadro del Mediterraneo Allargato: sappiamo che il nostro Paese ha avviato con Islamabad un partenariato strategico che riguarda principalmente temi legati alla Difesa e alla sicurezza. Questo improvviso vuoto è in fase di riempimento, con le dovute cautele che si sono rese necessarie dall’atteggiamento del regime talebano, dalla Cina, con la Russia che è, invece, rimasta più sullo sfondo e che ora rischia di venire estromessa dal suo “strano amico”.
L’estero vicino russo in Asia centrale è, infatti, in fermento e Pechino è pronta a subentrare a Mosca come potenza globale di riferimento. Il conflitto in Ucraina ha dimostrato che la Russia è una potenza in declino. Dal crollo dell’Unione Sovietica, la nomenklatura di gran parte dell’Asia centrale ha considerato Mosca come una forza e una presenza costante, immanente, rivolgendosi al Cremlino per risolvere le loro controversie interne e per avere un ombrello di sicurezza attraverso accordi bilaterali e multilaterali nel quadro dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (Csto – Collective Security Treaty Organization).
L’invasione di febbraio ha invece mostrato quello che, in realtà, era già evidente da tempo: la Russia non è in grado di gestire le crisi nel suo vicinato in modo efficiente; la sua potenza militare convenzionale, che fungeva da garante della stabilità, vacilla. Quindi, come sempre accade, quando il centro dell’impero è in declino, esso si frammenta. I recentissimi conflitti tra Armenia-Azerbaigian e Kirghizistan-Tagikistan dimostrano come Mosca sia stata accantonata dalle sue ex colonie. Anzi. Dimostrano come Mosca stessa sia incapace di controllarle stante il rifiuto di intervenire in Nagorno-Karabakh dopo che Yerevan aveva fatto ufficialmente appello all’intervento delle forze del Csto.
Questo vuoto di potere in Asia Centrale (e Caucaso) creatosi in modo quasi improvviso, ma non imprevedibile, sta colmandosi grazie alla sempre maggiore penetrazione di due attori internazionali: uno di livello globale, la Cina, uno di livello regionale, la Turchia. Pechino e Ankara sono i due principali protagonisti sia della mediazione nei conflitti regionali in atto, sia della sostituzione della presenza commerciale/economica russa nell’area, ma non sono i soli. Tra i Paesi di quella regione c’è anche chi guarda con interesse all’Europa e agli Stati Uniti: il Kazakistan, ad esempio, da tempo ricerca un legame più agevole col Vecchio Continente per questioni energetiche (più volte osteggiato dalla Russia generando notevole irritazione ad Astana), mentre il viaggio della presidente della Camera dei rappresentanti statunitense Nancy Pelosi in Armenia (questa volta concordato con la Casa Bianca) dimostra come il Paese stia sempre più cercando di slegarsi dalla pesante influenza russa aprendosi all’Occidente e dimostra tutto l’interesse statunitense per questa possibilità.
L’Asia Centrale (e in minor parte il Caucaso) torna a essere il fulcro del “Grande Gioco”, ma stavolta senza più “l’orso russo” e il “leone britannico”, ma col “dragone cinese” e “l’aquila statunitense”. La Cina parte sicuramente avvantaggiata in questo nuovo schema geopolitico: gli “-stan” orientali possono essere considerati “estero vicino” di Pechino, ma non è da sottovalutare la possibilità che Usa e Ue possano intessere relazioni con la parte più occidentale della regione.
Cosa succederà nei prossimi anni? Fare previsioni è sempre difficile, soprattutto quando si parla di quella particolare parte di globo, ma possiamo provare a ipotizzare due scenari possibili.
Il primo scenario: quello ottimista
Quello più ottimista vede la debolezza della Russia come un’opportunità per l’apertura della regione ad attori più liberali come gli Stati Uniti e Unione Europea. Questi potrebbero sfruttare il passaggio generazionale che vede la sparizione delle vecchie élite “sovietiche” per incoraggiare gli stati eurasiatici più piccoli a “guardare a occidente”, seducendoli con investimenti continui, partenariati economici e sviluppando meccanismi di cooperazione regionale anche a livello di sicurezza e difesa in cui tutti possono avere il proprio ruolo nel garantire che l’Asia centrale emerga più democratica e sicura. In questa visione, forse un po’ troppo semplicistica, la Cina resterebbe un semplice concorrente economico/commerciale e non reagirebbe in maniera assertiva o aggressiva.
Il secondo scenario:
La realtà però potrebbe essere diversa. Questa concorrenza alla penetrazione turco-cinese, più “illiberale” ma sicuramente più pervasiva sebbene in modo diametralmente opposto (quella di Pechino grazie al debito infrastrutturale, quella di Ankara attraverso affinità culturali), richiederebbe un piano strategico che sicuramente andrebbe a cozzare con gli interessi del gigante asiatico. Quindi si potrebbe aprire il peggiore degli scenari possibili. Pechino, considerando l’Asia Centrale come suo “estero vicino”, per tutelare i propri interessi, che sono già ampiamente presenti nell’area, potrebbe facilmente ricorrere ad azioni via via più assertive in un modus operandi già visto nel Mar Cinese Meridionale o nella regione di Taiwan: piccole ma costanti azioni progressive che culminerebbero con un “fait accompli” in cui i Paesi eurasiatici più orientali, o comunque quelli più strategici, diventerebbero satelliti della Cina, non escludendo nemmeno il possibile ricorso alla forza militare sebbene con operazioni a bassa intensità o magari su stessa richiesta dei diretti interessati.
Del resto non è un segreto che Pechino, col conflitto in Ucraina, abbia spostato la sua rotta verso l’Europa dalla Russia all’Asia Centrale, e quindi non starebbe a guardare la caduta di uno dei Paesi di quest’area nella sfera di influenza di una nazione ostile come gli Stati Uniti.