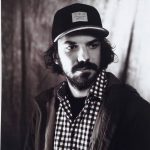A più di sei mesi dalle elezioni presidenziali nella Repubblica Democratica del Congo, la situazione interna al Paese rimane tutt’altro che stabile. Félix Tshisekedi, la cui vittoria è stata confermata a gennaio 2019, si trova infatti davanti a numerosi problemi da risolvere: le accuse di brogli, i focolai di ebola presenti nelle regioni nordorientali, e le continue violenze dei gruppi paramilitari nell’Ituri e nel Kivu sono soltanto alcuni dei punti caldi per il nuovo presidente, il cui partito è in minoranza in parlamento e, ad oggi, rimane incapace di formare un governo.
Tutto è in bilico a Kinshasa
Nonostante la sua elezione a quinto presidente del Congo, il primo a ricevere il potere in maniera pacifica dal 1960, anno dell’indipendenza dal Belgio, Tshisekedi è stato costretto fin da subito a fronteggiare la diffidenza dell’opinione pubblica interna ed estera, che in alcuni casi lo accusa esplicitamente di aver manipolato i risultati elettorali. Sia la Chiesa cattolica che l’Unione Africana, presenti come osservatori, hanno infatti dichiarato di ritenere Martin Fayulu il vero vincitore, nonostante i dati ufficiali confermino la sua sconfitta con un margine del 4% e sebbene ogni ricorso sia stato respinto dalla Corte costituzionale: un’opinione condivisa però da un’inchiesta congiunta del Financial Times e Radio France Internationale, che attribuisce a Fayulu quasi il 60% dei voti totali. L’ipotesi di collusione tra Tshisekedi (figlio di Étienne, tre volte Primo ministro negli anni Novanta) e il presidente uscente Joseph Kabila (il cui padre, l’ex presidente Laurent-Désiré, venne assassinato nel 2001), ventilata dalle opposizioni, sarebbe inoltre confermata dall’insolita composizione del parlamento, che ha visto andare la maggioranza assoluta dei seggi (341 su 500) al Fronte Comune per il Congo, il partito dello stesso Kabila, nonostante il relativo flop del suo candidato presidenziale alle elezioni, Emmanuel Ramazani Shadary, arrivato terzo e ultimo con il 23% dei voti. Il controllo esercitato dall’FCC su Senato e Assemblea Nazionale lo rende di fatto capace di controllare ogni futura decisione di Tshisekedi e del suo partito, l’Udps, oltre che di nominare un proprio Primo ministro: per questo motivo, il nome del capo di governo è stato annunciato soltanto lo scorso maggio, con la nomina informale del 72enne Sylvestre Ilunga, ma si prevede che la composizione del gabinetto non verrà confermata e annunciata sino almeno al 15 luglio.
L’epidemia di ebola nel Kivu del Nord
La provincia del Kivu settentrionale, all’estremo ovest del Paese, sta da tempo vivendo una gravissima situazione di emergenza legata all’ebola, la cui epidemia scoppiata nell’estate 2018 è considerata una delle più gravi di sempre, seconda soltanto a quella registrata in Africa Occidentale tra il 2013 e il 2016. A undici mesi dall’inizio della crisi, il cui epicentro si trova nella città di Beni ed è stato provocato da un ceppo diverso rispetto alle precedenti occorse in Congo, lo Zaire ebolavirus, sono stati confermati 2782 casi e 1613 vittime: altre tre morti sono avvenute a giugno nel vicino Uganda, coinvolgendo un bambino congolese di 5 anni rifugiatosi nel Paese e altri due membri della sua famiglia. La stessa Beni è stata recentemente e più volte attaccata dall’organizzazione paramilitare Adf, che si sospetta essere legata allo Stato Islamico, sommandosi alle continue tensioni tra gruppi armati locali: si stima che nel Kivu (includendo anche la sua controparte meridionale) ne siano attivi circa un centinaio, a causa dei quali è spesso difficile proseguire con le attività di contenimento e vaccinazione contro il virus dell’ebola. A tutto questo, vanno aggiunti gli attacchi che hanno coinvolto direttamente i centri medici e gli ospedali nel cuore dell’area colpita, provocando paura e riluttanza a farsi vaccinare nella popolazione locale e il ritiro di alcuni importanti enti umanitari come Oxfam. Per questo motivo, si stima che a maggio 2019 il numero di nuovi casi oscillasse tra i 70 e i 110 alla settimana, più del doppio rispetto al febbraio precedente, con l’ipotesi di uno scoppio dell’epidemia anche in Ruanda.
Massacri di civili e accuse di genocidio
A nord del Kivu, nella provincia dell’Ituri, il mese appena trascorso ha visto riaccendersi la fiamma del conflitto che vede opposte le etnie dei Lendu e degli Hema (questi ultimi sostenuti da Kinshasa e dall’Uganda), a sua volta riaccesosi nel dicembre del 2017 dopo una tregua durata quattordici anni. Questa guerra, nata dall’opposizione etnica creatasi in epoca coloniale e acuitasi in seguito al genocidio in Ruanda negli anni Novanta, era infatti giunta a uno stop grazie all’impiego di una missione Onu, ritiratasi proprio due anni fa. Dopo una serie di attacchi improvvisi e dispute territoriali sempre più accese, nel giugno 2019 si sono registrati più di duecento morti e circa 300.000 sfollati, molti dei quali hanno chiesto asilo nei Paesi vicini: la regione è inoltre colpita a sua volta dall’ebola (219 casi confermati), dalla diarrea, dal morbillo e dalla malaria, aggravate dal continuo movimento di sfollati e rifugiati nella zona. Lo stesso Tshisekedi, in visita nell’area lo scorso 2 luglio, ha definito i continui massacri “un tentativo di genocidio” e “un complotto” ordito dalle milizie Lendu, ribadendo la sua volontà di ristabilire l’autorità dello Stato attraverso un intervento militare su ampia scala delle Fardc, l’esercito congolese. Ma con il proprio stesso potere messo costantemente in discussione e un’epidemia devastante che non accenna a fermarsi, sarà in grado di farcela? La risposta, ad oggi, rimane negativa.