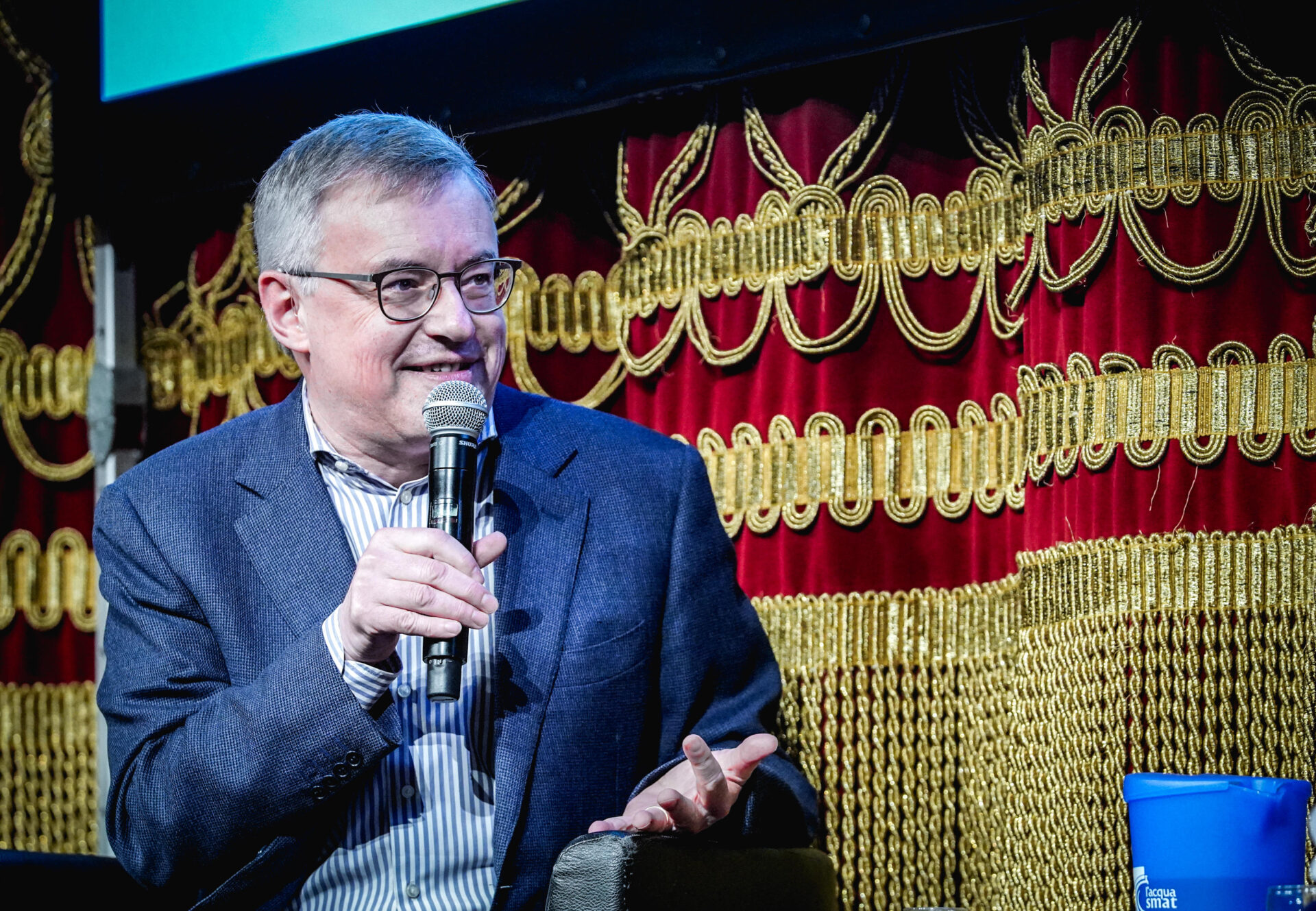All’inizio della settimana, le etichette di “informazione falsa” che gravavano sui video di Alessandro Barbero, oscurato da Meta (cioè Facebook) su indicazione del sito Open, sono evaporate dalle bacheche. Senza alcuna spiegazione. Se, come tutto lascia supporre, è stata la stessa Open – e il suo debunker-principe, David Puente – a procedere alla ritirata, dopo le polemiche di questi giorni, ci troviamo di fronte a un atto di pentimento che suona una campana a morto per i difensori d’ufficio della censura.
Eppure in questi giorni abbiamo assistito al consueto spettacolo di un’intellighenzia pronta a immolarsi sull’altare del “dispositivo”. Intellettuali filogovernativi, da un lato, e di sinistra euro-atlantista col dente avvelenato per il Barbero contrario al riarmo e sempliciotto sull’Ucraina si erano affrettati a giustificare il provvedimento, elevando lo storico a cazzaro da silenziare in nome della sicurezza pubblica. Open se l’è cavata con una mossa che è difficile non leggere come un maldestro tentativo di damage control.
Chi scrive non ha mai tenuto troppo conto delle opinioni di Barbero sulle crisi del presente, fosse anche solo per la vocina un po’ insolente con cui vengono somministrate, e non crede che questo piccolo scandalo possa risollevare il fronte del No al referendum, che è rappresentato da alcuni magistrati-macchiette che più parlano e più fanno danni.
Questa vicenda però non riguarda solo Barbero o i suoi nemici. Riguarda, diciamo la verità, anche quel progressismo che per anni ha cullato l’illusione che i colossi della Silicon Valley fossero alleati naturali, guardiani illuminati contro il “barbarismo” populista. E oggi, quel presunto Democracy Shield avallato dall’Ue per combattere la “disinformazione” dei suoi nemici esterni somiglia sempre più a una censura maccartista e imbranata.
Se anche Barbero avesse presentato il suo intervento condendolo dall’inizio alla fine di svarioni, resterebbe il problema del doppio standard. Viviamo in un ecosistema informativo dove opinionisti di grande fama possono evocare gli “scudi umani” di Hamas per giustificare massacri indiscriminati a Gaza, o descrivere truppe russe contemporaneamente allo sbando e pronte a invadere Lisbona, senza mai subire l’umiliazione del bollino. Lì la possibilità dello svarione è ammessa; per altri no.
Esiste una forma di hybris tutta contemporanea che consiste nel credere che la verità politica sia una grandezza misurabile in laboratorio. Se accettiamo che un’agenzia privata possa silenziare un’analisi politica perché “allarmistica”, stiamo accettando la fine dello spazio pubblico. In una società sana, le opinioni devono poter restare sensazionaliste, apocalittiche o persino irragionevoli, senza un padre superiore, uno zelante interprete dell’algoritmo ci dica ogni volta cosa è fuorviante.
Eppure questa volta abbiamo assistito a un fenomeno raro: una frattura interna alla nuova casta dei mediatori. Se Puente ha interpretato un ruolo forse troppo grande per lui, quello dell’incaricato di purgare i rumori non conformi (“Per fare il debunking di una profilazione razziale della polizia chiese alla polizia “avete fatto profilazione razziale?” E in base a quello disse che non si era trattato di profilazione”, mi scrive un collega un po’ cattivello che vuole restare anonimo) altri siti di fact-checking hanno preferito ritirarsi su posizioni di prudenza dottrinale. Probabilmente non per spirito libertario, ma per salvare la funzione stessa del fact-checking dal rischio del ridicolo e, soprattutto, dall’irrilevanza.
Per Pagella Politica, l’errore di Open risiede in una confusione categoriale. Nel video di Barbero, lo storico non si limita a enunciare dati, ma esercita la funzione critica del cittadino, traendo conclusioni politiche da premesse tecniche. Il fact-checking, nella visione di Pagella Politica, dovrebbe fermarsi sulla soglia del dato presente. Questa la frase chiave: “Il video di Barbero contiene sì alcune affermazioni fattuali discutibili, ma è composto in larga parte da valutazioni politiche e giudizi sugli effetti futuri della riforma, che secondo le stesse regole del programma Meta non dovrebbero essere oggetto di etichettatura”.
Tentare di smentire come “falsa” una previsione sul futuro (l’allarme di Barbero su una deriva autoritaria) significa insomma uscire dal dominio della scienza per entrare in quello della divinazione burocratica. È la pretesa di verificare l’invivibile, oppure di sottoporre a test di laboratorio il sentimento politico.
Dal canto suo, Facta (che insieme a Open gestisce il programma di fact-checking di Meta) solleva una questione di pura governance delle piattaforme. Richiamando i protocolli del colosso-capo, il sito ci ricorda che le opinioni sono, per statuto, escluse dalla giurisdizione del bollino giudicante, e che l’interpretazione dei fatti è il cuore pulsante della dialettica democratica. Insomma, ci sta dicendo che Open ha censurato delle opinioni.
Siamo di fronte alla messa a nudo di un clericato di debunker che, nel tentativo di proteggere la democrazia dalle insidie del populismo, finisce per svuotarla di ogni contenuto dialettico. Ogni “ente terzo” investito di un ruolo così grande compie scelte e, di conseguenza, introduce inevitabilmente dei bias, anche ideologici. Ma il problema si aggrava quando il debunking diventa meccanico o ridicolo, finendo per validare versioni ufficiali di governi, eserciti e forze dell’ordine senza un vero controllo critico. Una brutta storia, questa. Ma nella quale la sinistra tecno-ottimista non può sentirsi assolta.