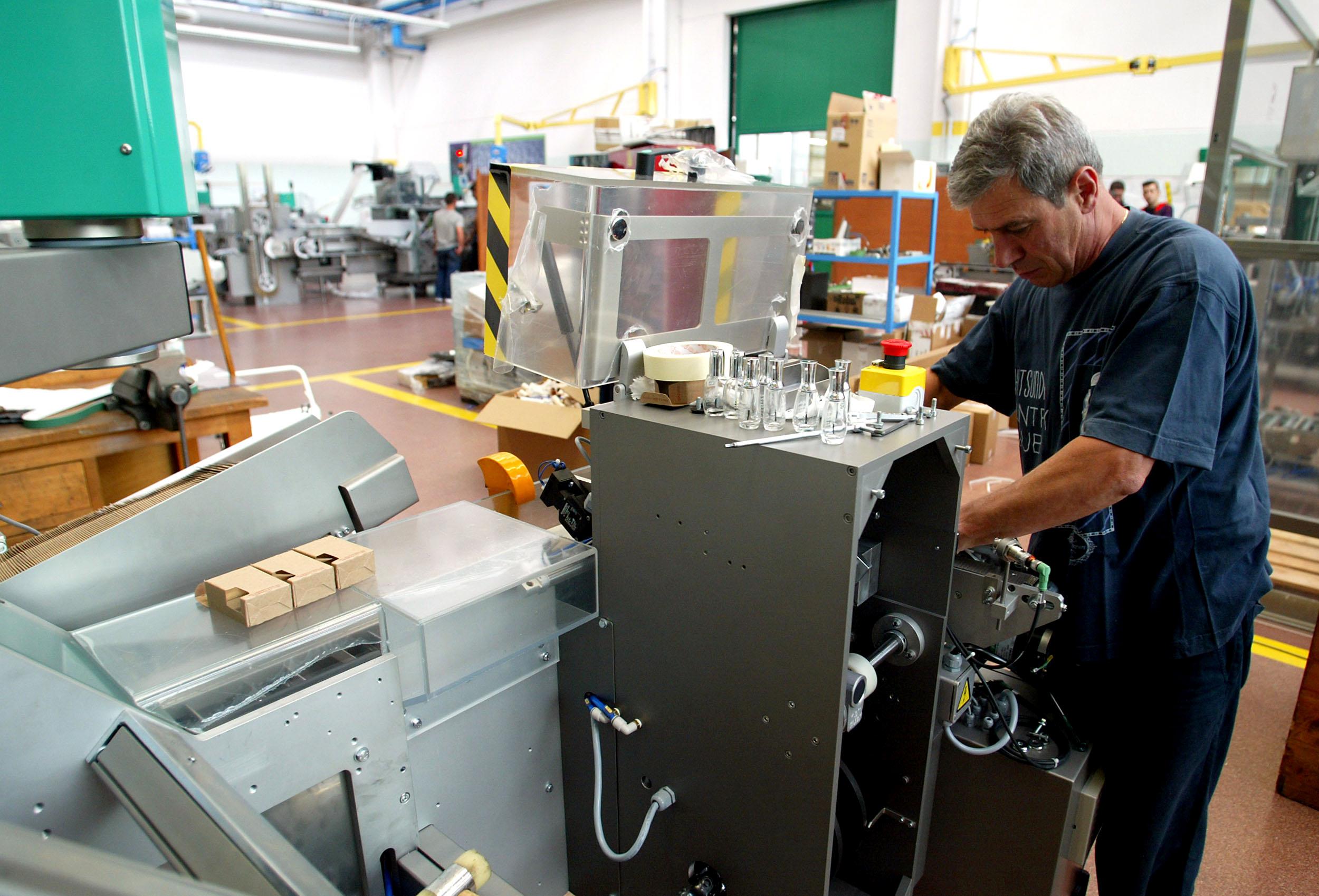Cercata a lungo dalla Banca centrale europea, temuta dai rigoristi più ferrei, l’inflazione è esplosa nella seconda metà del 2021 in tutta Eurolandia, trainata dalla ripresa delle attività economiche post-Covid, dalle riaperture dovute ai vaccini e dal rilancio nell’economia dei risparmi tenuti per un anno e mezzo congelati dai lockdown. Salvo poi decollare sulla scia della bomba dei prezzi energetici e della destrutturazione globale delle catene del valore. L’Europa è stata travolta dalle onde dello tsunami inflattivo: rincari, necessità di acquisizione di materie prime dall’estero, speculazione finanziaria hanno creato il rischio di una tempesta perfetta. Di cui la Bce ha dovuto prendere atto.
Mentre la Federal Reserve avvia l’uscita dagli stimoli anti-pandemia e procede al graduale aumento dei tassi di interesse sul denaro, la Bce si trova di fronte alla necessità di affrontare anche le conseguenze di una guerra, quella tra Russia e Ucraina, il cui conto in termini di effetti delle sanzioni e rincari sarà, nel campo occidentale, principalmente in capo all’Europa. La quale si troverà a dover finanziare misure da economia di guerra, ad aggiornare, si pensa, il piano Next Generation Eu con nuovi finanziamenti e a gestire scenari globali di incertezza e volatilità. E anche ai vertici dell’Eurotower si ragiona sul fatto che la guerra possa “mettere in moto nuovi trend inflazionistici che richiedono un pò di tempo per manifestarsi”. Parola della governatrice della Bce Christine Lagarde, che intervenendo alla conferenza “The Ecb and Its Watchers XXII” ha mostrato i dati preoccupanti per l’inflazione.
“Le ultime proiezioni di base dello staff della Bce – che includono una prima valutazione dell’impatto della guerra – vedono l’inflazione, in media, al 5,1% quest’anno. In uno scenario più severo, l’inflazione potrebbe superare il 7% nel 2022”. Per anni il quantitative easing con i suoi tentativi di aumentare lo stock di valuta a disposizione dell’Eurozona ha mirato a mantenere moderatamente in ascesa l’inflazione nell’economia reale, gestendo con difficoltà la necessità di un target del 2%. Ora l’inflazione è esplosa e, complice l’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro, si paga in tutti i settori in cui l’Europa è vulnerabile: energia, materie prime, catene del valore industriali, produzione industriale, rilancio dell’economia.
L’inflazione non ha ancora raggiunto i livelli toccati negli Stati Uniti, dove la Fed sta promuovendo la stretta monetaria per ovviare ai problemi di surriscaldamento dell’economia: ma i piani da oltre 2 trilioni di dollari messi in campo dall’amministrazione Biden per sostenere l’economia reale e la ripresa, che è partita con slancio, negli Usa, non hanno niente a che vedere con la ben più timida risposta europea. La Bce si trova di fronte a un complesso trilemma: la Lagarde e i suoi devono scegliere se promuovere misure volte a sostenere un nuovo piano di rilancio, lasciando dunque correre l’inflazione ulteriormente, ma senza garantire stabilità all’euro. Oppure possono stringere sull’inflazione e stabilizzare l’euro colpendo però l’economia reale. Terza strada è il mix tra nuovi piani di acquisto titoli mirati e stretta monetaria su altri fronti, che avrebbe però effetti incerti sull’inflazione.
Nel suo intervento Lagarde sottolinea che a suo avviso “è improbabile che torneremo alle stesse dinamiche di inflazione” precedenti alla pandemia di Covid-19. All’inizio della quale, del resto, ha compiuto diversi scivoloni che hanno portato a un vero e proprio commissariamento ad opera del capo economista Philip Lane. Pertanto, l’Eurotower, dice la Lagarde, è “consapevole dei rischi sottostanti causati dalla guerra e dell’incertezza” che il conflitto sta creando “in tutte le direzioni”. Di fronte al rischio che all’elevata inflazione si aggiunga una dinamica di crescente stagnazione (stagflazione) l’ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale ha sottolineato che “tutte le decisioni di politica monetaria nei prossimi mesi” si baseranno “necessariamente” sulle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina e dipenderanno dai dati”. Dunque potrebbe essere promossa un’estensione del Pandemic Emergence Purchase Programm, che tra piani di acquisto titoli di circa un trilione di euro e operazioni di finanziamento a lungo termine (Tltro) ha mobiltiato 3mila miliardi contro la crisi.
La Fed ha già iniziato la fase di frenata, la Bce ha solo alzato il piede dall’acceleratore, non aprendo ancora all’aumento dei tassi. Rispetto ad alcune settimane fa l’economista francese è più cautelativa su questa opzione. “L’aggiustamento dei tassi d’interesse chiave della Bce – ha spiegato Lagarde – avrà luogo qualche tempo dopo la fine degli acquisti netti” di obbligazioni sovrane e private. “Questo”, ha spiegato, “mantiene la nostra logica tradizionale di sequenzialità, ma ci dà anche spazio extra se necessario, dopo aver smesso di acquistare obbligazioni e prima di fare il prossimo passo verso la normalizzazione”. Parole che aprono a quanto da tempo alcuni economisti lungimiranti sottolineano con chiarezza: l’idea che possa essere la sola politica monetaria a gestire l’inflazione è per ora fuorviante. Economisti come l’italiano Francesco Saraceno, docente a Science Po, da tempo lo mettono chiaramente in evidenza: in questa fase di acuta inflazione e volatilità reagire ad un aumento dei costi e a una bomba inflattiva con una stretta monetaria può forse ridurre l’inflazione ma solo a prezzo di uccidere l’economia. Quest’ossessione monetarista non lascia spazio ai margini di manovra della politica fiscale, che può e deve intervenire sui mercati: la Francia, ad esempio, ha stabilito che il rincaro massimo delle bollette, a prescindere dai livelli di inflazione, potrà essere nel 2022 del solo 4%. Operando una scelta politica chiara.
Gli Anni Settanta, in cui l’aumento dei salari e del prezzo del petrolio generò la tempesta inflattiva e la stagflazione, non stanno tornando. L’Europa e il mondo ora subiscono una crisi di offerta da un lato e una tendenza al ristagno dopo il rimbalzo delle economie post-Covid a cui si somma una complessa capacità di gestione degli shock legati alla pandemia. “Gli strumenti possibili” per Saraceno, come scritto in un recente tweet, “sono vari e ad orizzonti diversi: investimenti (pubblici e privati), incentivi, regolamentazione, misure amministrative” e non riguardano la sola politica monetaria.
🧵 "io l'avevo detto" su inflazione ed energia.
Qualche settimana fa, di fronte al ritorno dell'inflazione molti chiedevano politiche monetarie più restrittive
un esempio qui: https://t.co/XP7ZhTYK6x
1/— Francesco Saraceno (@fsaraceno) March 11, 2022
“Per gestire un momento storico in cui domanda e offerta hanno dinamiche complesse, in cui crisi epocali si intrecciano con mutamenti strutturali, non bisogna privarsi di alcuno strumento per mantenere l’economia in un corridoio di stabilità”, ha aggiunto Saraceno. Conclusioni importanti che invitano a pensare al cambio di prospettiva richiesto: per due anni la Bce ha sostenuto i debiti, coperto le richieste di finanziamento, aperto canali di sostenibilità per l’Europa di fronte alla crisi pandemica. Tempesta energetica e guerra in Ucraina invitano oggi a compiere, sul fronte fiscale, mosse ardite e strategiche di ben più lungo respiro. La Lagarde, tra le righe, lo ha ammesso: portare l’inflazione a livelli sostenibili è anche compito dei governi e delle loro scelte, che dovranno agire per ridurre i costi per i cittadini di queste politiche a patto di non decapitare la ripresa economica. Il trilemma di cui sopra non si potrà risolvere senza l’intervento della leva decisiva dell’azione dei governi.