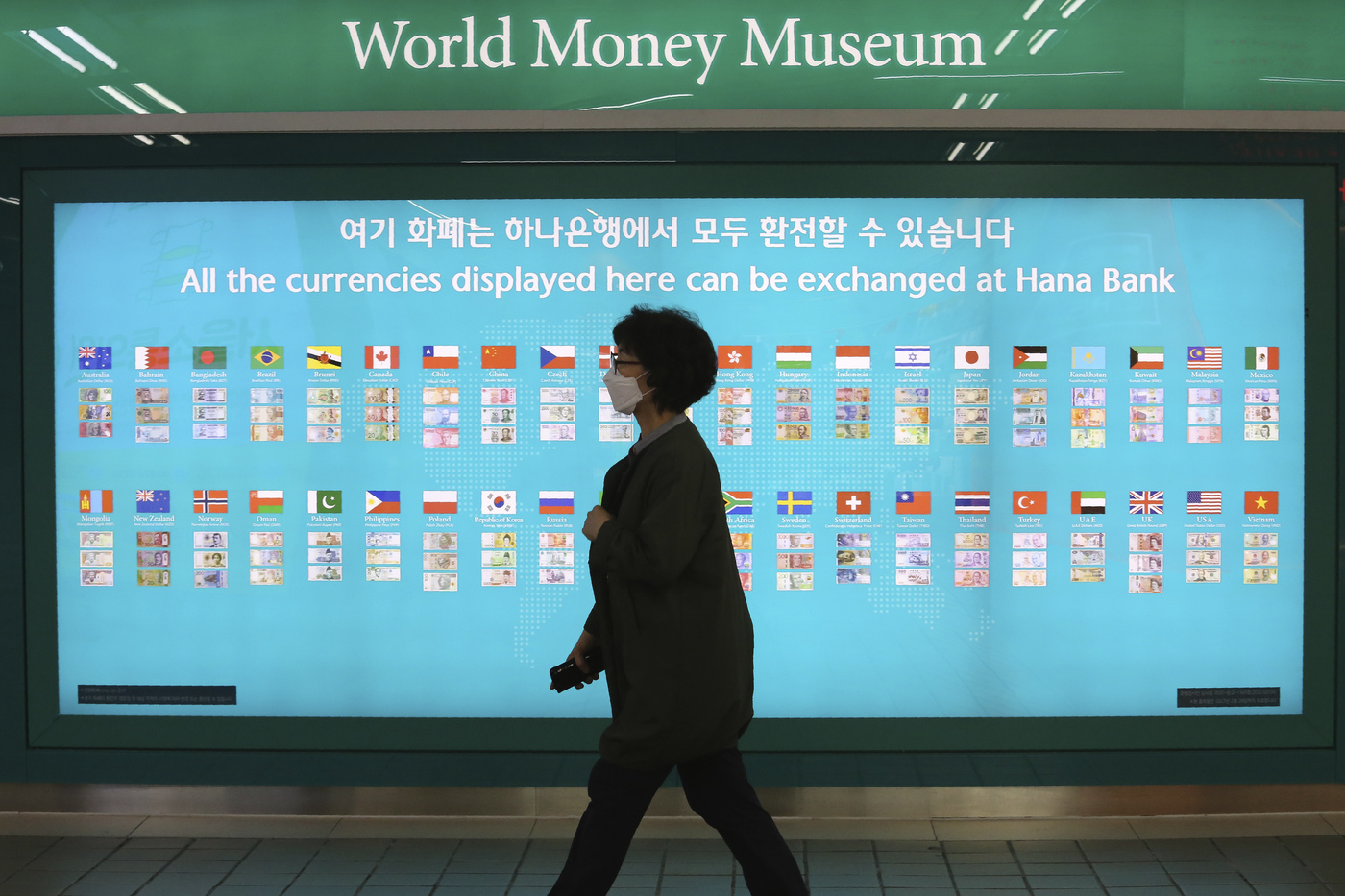Nel contesto del mondo del fisco europeo si torna a parlare del Lussemburgo, e a quasi sette anni dai LuxLeaks, le rivelazioni dell’International Consortium of Investigative Journalists sul regime fiscale favorevole con cui il Granducato attirava permettendo negoziazioni ad hoc le multinazionali di tutta Europa (e non solo) desiderose di incontrare condizioni di tassazione favorevoli la partita sembra esser tornata al punto di partenza.
L’inchiesta “LuxLetters”, condotta da Le Monde, Süddeutsche Zeitung, El Mundo, Woxx e IrpiMedia, con le ONG Tax Justice Network (TJN) e The Signals Network sta in queste settimane mettendo sotto inchiesta i dichiarati sforzi con cui il Lussemburgo ha voluto guardare oltre la fase di apertura totale alle multinazionali coincisa con la lunga era di governo di Jean-Claude Juncker. Passato politicamente indenne nel quinquennio alla guida della Commissione europea allo scandalo che rilevò 540 accordi firmati dal suo esecutivo con 340 compagnie di 26 diversi Paesi per concordare condizioni fiscali favorevoli. Ora il Lussemburgo dichiara di volersi sganciare dalla nomea di paradiso fiscale e, sottolinea Le Monde, di aver optato per una politica di trasparenza: le “sentenze”, gli accordi bilaterali tra Lussemburgo e multinazionali, secondo l’esecutivo del Granducato, “sono diminuiti del 90%, con solo 44 sentenze firmate nel 2020. Non appena rischiavano di danneggiare un altro Stato europeo dal punto di punto di bilancio, sono stati trasmessi a quest’ultimo, in conformità delle norme europee”.
Ma le cose stanno davvero così? “LuxLetters” ritiene di no e, anzi, che senza aver veramente fatto una legge anti-elusione a Lussemburgo abbiano, preventivamente, trovato l’inganno. Il nuovo stratagemma assume la forma di una lettera con la quale un esperto fiscale incaricato della revisione del bilancio di una grande compagnia (società di consulenza o studio professionale) informa l’amministrazione lussemburghese del vantaggioso trattamento fiscale di cui il proprio cliente (generalmente una società o un fondo di investimento) intende beneficiare e per il quale varrebbe la pena di approvare il silenzio delle autorità.
Di fatto, fuori dalle regole e in maniera di fatto informale in questo modo governo e società contabili pianificano il fisco ex ante senza dover lasciare il segno ufficiale dei numerosi tax ruling concordati nella prima decade del nuovo millennio. Il ruolo delle società contabili passa dunque da quello di determinante effettivo dei tax ruling a quello di consulente informale per una pratica che nella sostanza non è diversa in termini di risultati.
Italia Oggi sottolinea in ogni caso che “tale pratica è proibita dalle direttive Ue ed è probabilmente contraria alle regole Ocse sullo scambio dati. Infatti, qualsiasi tipo di accordo fiscale, anche se non legalmente vincolante, deve essere scambiato con le altre autorità fiscali” e non può ricevere intermediazioni informali. In sostanza, l’accusa al Lussemburgo è che il Granducato starebbe riciclando la sua immagine semplicemente facendo entrare dalla porta di servizio ciò che prima veniva fatto entrare dall’ingresso principale: i miliardi di euro delle compagnie che inseguono condizioni fiscali più utili alle loro priorità di business e sfruttano i numerosi accordi sul blocco della doppia tassazione che uniscono i Paesi Ue, al cui interno si vanno formando veri e propri paradisi fiscali.
I paradisi fiscali interni all’Europa, che hanno il loro epicentro nel Lussemburgo, nell’Irlanda e nell’Olanda, rappresentano un fattore di destabilizzazione economica e politica del Vecchio Continente. L’utilizzo dei favoritismi fiscali come arma di competizione economica drena risorse da Paesi basati su economie maggiormente orientate all’industria e alla trasformazione. L’Italia, per fare un paragone, nel campo degli utili d’impresa applica un’aliquota del 28% che scende al 26,9% nel caso limite di massimi sconti fiscali. Il Lussemburgo è il vero campione in materia di deduzioni, presentando un’aliquota che dal 26 può crollare fino allo 0,3%. Nel giugno 2020 in una audizione alla Camera dei Deputati, il presidente di AgCom Roberto Rustichelli ha sottolineato che “la concorrenza fiscale sleale genera evidenti vantaggi per taluni Paesi: il Lussemburgo, paese di circa 600 mila abitanti, è in grado di raccogliere imposte sulle società pari al 4,5% del PIL, a fronte del 2% dell’Italia”. Impietoso il confronto sugli investimenti esteri, che il Granducato attira per un valore pari al 5.760% del Pil contro il 19% nazionale.
Come qualificare se non come veri e propri furti al resto d”Europa queste pratiche? Nell’era del Covid-19 la pratica della concorrenza sleale in materia fiscale è di rilevanza globale. E la presenza di Paesi che esplicitamente barano cercando l’abboccamento con le multinazionali per drenare risorse dagli erari degli altri Stati è un fattore di perturbazione dell’equilibrio politico ed economico che può pesare sulle prospettive di ripresa del Vecchio Continente. La fiscalità allegra del Lussemburgo è forse la peggiore eredità lasciata da Jean-Claude Juncker all’Europa, anche più della sfiducia generata verso l’Unione e dei disastri compiuti in cinque anni di presidenza della Commissione: la sua istituzione ha generato un contesto pericoloso e competitivo di tutti contro tutti. In mezzo a cui gioca chi facilmente mette uno Stato contro l’altro per inseguire regimi di tassazione più favorevoli.