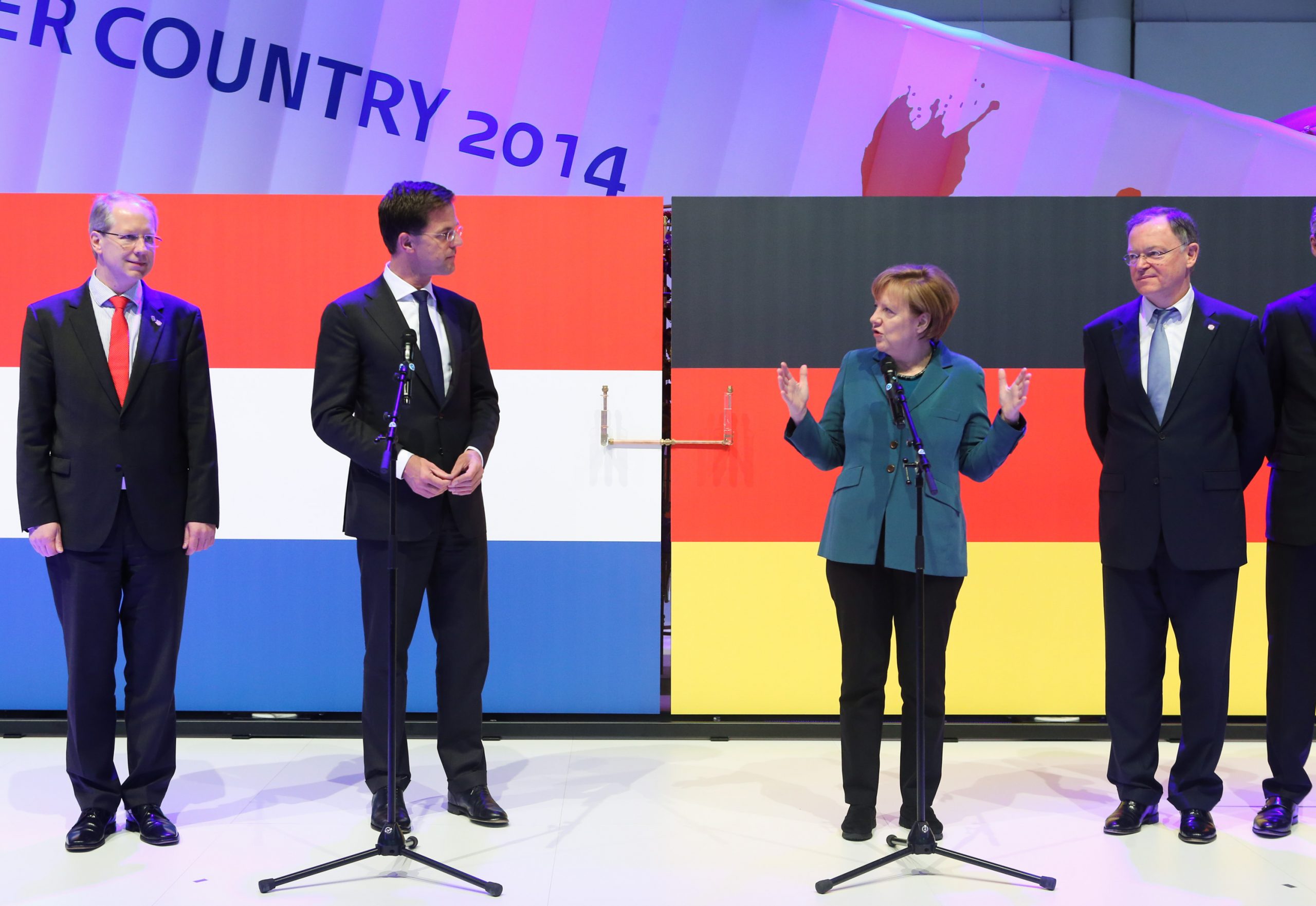Gli Eurobond, o “coronabond”, sono tornati nelle ultime settimane sul tavolo ad anni di distanza dalla prima proposta in sede comunitaria, opera dell’ex ministro dell’Economia italiano Giulio Tremonti e dell’ex presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Perorata soprattutto da Italia, Francia e Spagna, la causa dei titoli comuni dell’area euro è diventata la bandiera attorno a cui i Paesi dell’area mediterranea e latina dell’Unione si sono arroccati e trincerati in opposizione alla linea del rigore propria dei “falchi”: Germania, Olanda, Austria e Finlandia.
Il motivo dello scontro, in soldoni, è molto semplice. I quattro Paesi del Nord e Centro Europa dovrebbero fare ampie concessioni ai Paesi del Sud e del Mediterraneo in termini di appiattimento degli spread, redistribuzione del rischio e futuro politico dell’Unione accettando gli Eurobond. Il muro contro muro dei “falchi” e la loro decisione di impuntarsi in difesa del Meccanismo europeo di stabilità sono legati alla volontà di difendere un’altra “bandiera”, quella del rigore sui conti e della ridotta solidarietà europea, ma anche a un calcolo contabile spericolato. Ovvero l’attestazione che gli Eurobond favorirebbero, in quanto a rendimento e rischio, gli altri Paesi e che per loro continuerà a risultare conveniente finanziarsi agevolmente a tassi più bassi con gli ordinari titoli di Stato.
Con una battuta, si potrebbe dire che i nordici puntino ad avere la botte piena, ovvero la possibilità di agire sul fronte interno con energiche politiche di stimolo anticicliche, e la moglie ubriaca, ovvero la possibilità di essere esentati da qualsiasi solidarietà europea. In Italia questo approccio ha trovato un difensore nell’economista Roberto Perotti,che su Repubblica ha recentemente scritto: “è così strano che i Paesi nordici siano riluttanti? Al contrario della crisi del 2011, in questa ci sono di mezzo in pieno anche loro, e hanno davanti una incertezza enorme: è impensabile che si accollino anche il rischio di un Paese ad alto debito come l’ Italia. Nessun politico di un Paese nordico può assumersi la responsabilità di regalare o prestare i soldi del proprio contribuente all’ Italia e poi sentirsi rimproverare che quei soldi servivano nel loro Paese”.
Questo approccio sconta almeno tre limiti sistemici. Il primo è il rifiuto di considerare come comune la sfida del coronavirus ai sistemi economici d’Europa. Il secondo è l’incapacità di comprendere la diversità di questa crisi dalle precedenti che hanno colpito l’Europa, in quanto originata dallo choc di offerta legata al crollo della produzione per la serrata generale dei Paesi, e non da dinamiche prettamente finanziarie. Il terzo, infine, è legato alla dipendenza dall’ideologia dell’austerità come totem e il permanere del sottofondo moralista che traspare dalla stessa etimologia tedesca sull’equivalenza tra debiti e colpe. Come se non fossero valse le parole di Mario Draghi sull’inevitabilità di alti livelli di debito pubblico strutturale dopo la crisi come volano per la ripresa dei Paesi dell’Europa in crisi.
In fin dei conti, la scommessa dei falchi è riuscire a separare il proprio destino da quello del resto d’Europa. Un approccio pericoloso che il Vecchio Continente può pagare caro, primi fra tutti gli stessi rigoristi così focalizzati su sistemi economici export-led: come al solito, a ridurre le prospettive dell’Unione Europea sono, primi fra tutti, quegli Stati che delle sue linee politiche se ne fanno paladini.