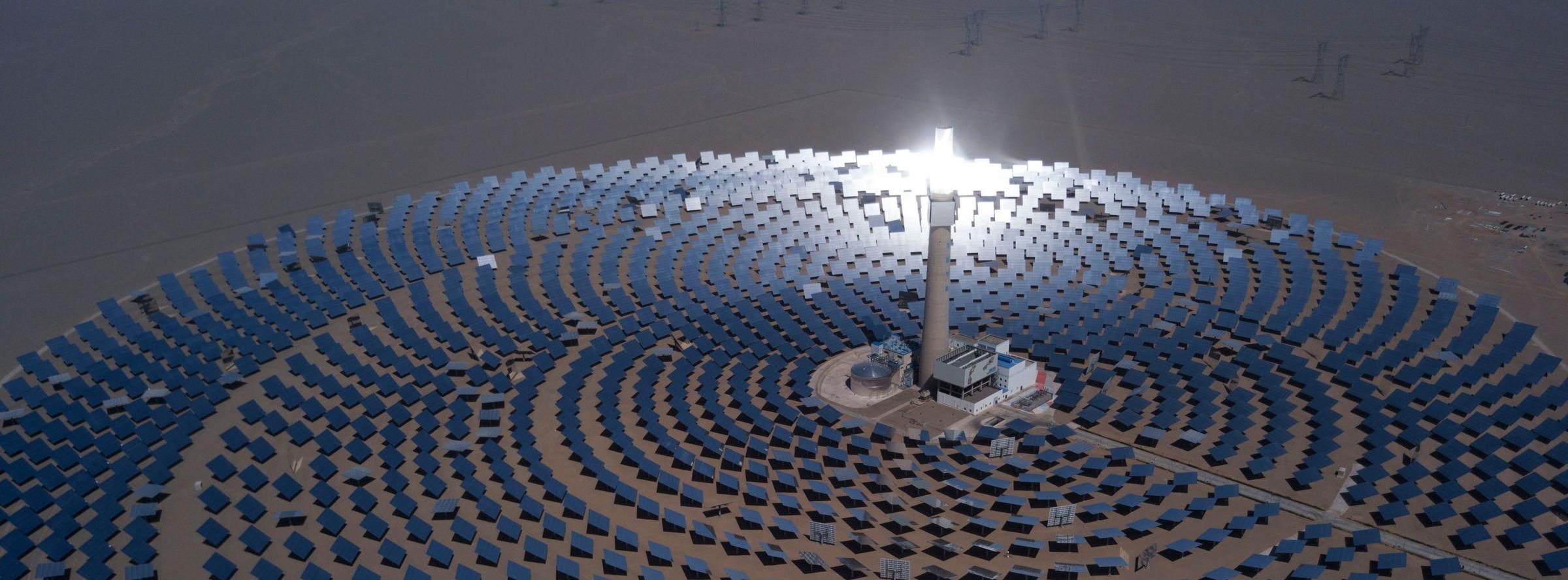La transizione energetica è oggigiorno una questione fondamentale per tutte le società a economia avanzata, i governi e i settori produttivi più strategici. Mentre gradualmente, tra ricerca di nuovi paradigmi, un crescente sentimento ecologista e la diffusione di nuove tecnologie, prende piede la più complessa e articolata ristrutturazione industriale mai promossa nella storia umana comincia ad apparire chiaro che questo processo non sarà, parafrasando Mao Zedong, un “pranzo di gala”.
In particolare, è sicuramente indubbio che i nuovi paradigmi produttivi, i nuovi settori legati all’energia rinnovabile, l’efficienza come nuovo driver dell’industria e i nuovi servizi in via di sviluppo (pensiamo solo agli smart charger e alla domotica) presuppongono una crescente ibridazione tra espansione produttiva e tutela ambientale, ma d’altronde le aspettative devono esser mediate con la realtà. Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani, i ministri del governo Draghi più attenti alle dinamiche della transizione ecologica sul fronte scientifico e industriale hanno avvertito che l’ideologia ambientalista più radicale può portare a fare della transizione ecologica un “bagno di sangue” per le economie avanzate. E al contempo va sottolineato che anche nel contesto di una programmazione strutturata e realista, come in parte quella italiana è, i danni fisiologici non sono da escludere.
Questo per un’ampia e complessa serie di ragioni strutturali. Gli investimenti per la transizione, in primo luogo, costano: i piani miliardari di Enel e Terna per le reti elettriche di ultima generazione e le proposte di investimento di Paesi come la Germania sull’idrogeno lo testimoniano. Questo presuppone per le imprese una necessità crescente di programmazioni di medio-lungo periodo cui vanno fatti seguire cicli di assunzioni di figure specializzate, questioni burocratiche con cui fare i conti, analisi di mercato complesse, piani di finanziamento che devono essere ben oculatamente strutturati. Pena flop potenzialmente rovinosi.
Questo si lega direttamente al secondo tema nel disegnare un quadro che rende come unica strada percorribile quella dell’ambientalismo pragmatico: le imprese e le altre creature del mondo economico possono pensare sul lungo periodo a piani radicali, ma si trovano a vivere in un “qui e ora” fatto di mix energetici ancora dipendenti dal contesto governato dalle fonti non rinnovabili. Parlando con Affari Italiani l’imprenditore e manager Domenico Greco, che attraverso la holding Gestioni Industriali è un attore di primo piano nella chimica italiana e si è fatto a lungo interprete della linea pragmatica sulla transizione, lo ha testimoniato: “Le nostre aziende operano attraverso processi elettrolitici che, se da una parte si possono definire “puliti” perché impiegano acqua, sale ed energia elettrica come principali materie prime, dall’altra vedono il loro posizionamento competitivo direttamente connesso al costo dell’energia elettrica e del gas (in quanto materia prima per la produzione della stessa energia elettrica)”.
Greco sottolinea dunque l’impossibilità di scindere la transizione dalle dinamiche attuali di mercato. La dipendenza delle imprese dal bilancio, dalla necessità di evitare shock sistemici e interruzioni nelle disponibilità di flussi di cassa continui e dalla capacità di programmare organicamente le rende strutturalmente sensibili a problematiche legate al balzo del prezzo dell’energia. Questioni potenzialmente in grado di inficiare e rallentare le strategie di lungo periodo come il piano europeo Fit for 55, dato che i costi dell’energia, soprattutto quella elettrica, dipendono fondamentalmente dalle materie prime e dal processo con cui questa viene prodotta.
Questo ci introduce al terzo e ultimo punto che imprese e governi dovranno affrontare nel gestire la transizione: quello delle catene logistiche, che Greco nel suo dialogo con Affari Italiani tocca. “L’unica maniera di far fronte a questa emergenza”, nota, “è di privilegiare il più possibile fornitori locali cercando di costruire una supply chain europea che quindi possa in parte contenere i rischi di discontinuità logistiche e di costo”. Il reshoring industriale e la trasformazione strutturale delle catene del valore globali non potrà non riguardare anche i settori chiave per la transizione, che impattano anche su filiere fortemente strategtiche come quella delle tlc, dei semiconduttori e delle infrastrutture di connessione, in cui la capacità di proiezione degli Stati strateghi intenti a privilegiare i propri campioni nazionali si sta facendo sempre più attiva dopo il Covid-19.
La transizione passerà non attraverso lo smantellamento di settori economici ed industriali consolidati, ma dalla creazione di nuovi comparti e dall’evoluzione di quelli già esistenti grazie ai nuovi paradigmi tecnologici. Si pensi solo, un esempio per tutti, all’automotive. E questa sfida sarà trasversale per evitare che la transizione ecologica, promossa frettolosamente o mal congegnata, causi una moria di imprese, lo sfacelo di settori incapaci di stare al passo e la moltiplicazione di disoccupati o indigenti. Il “bagno di sangue” che grazie alla programmazione e la tecnologia si può e si deve evitare, usando la stella polare del realismo.